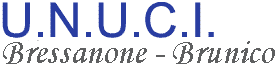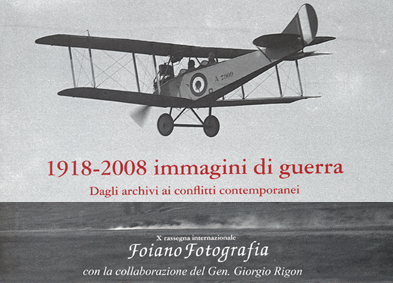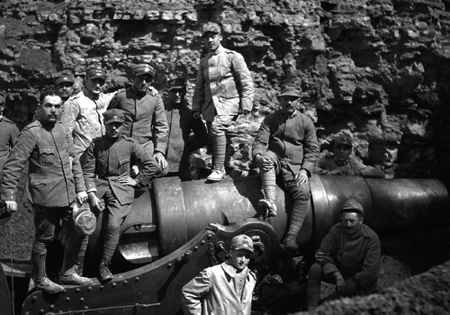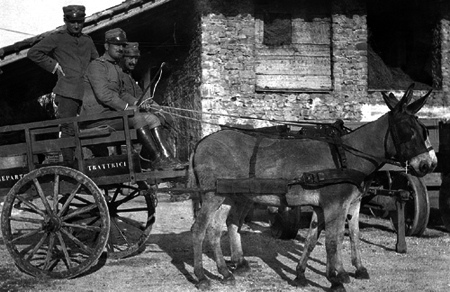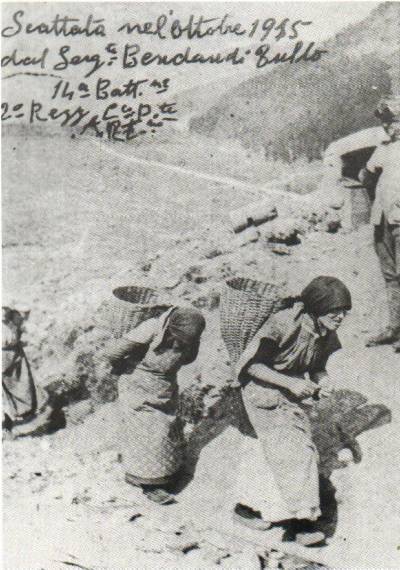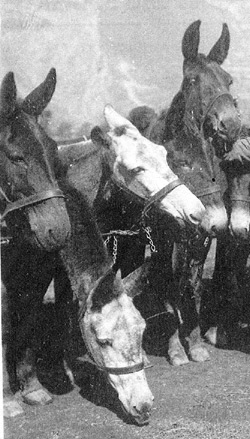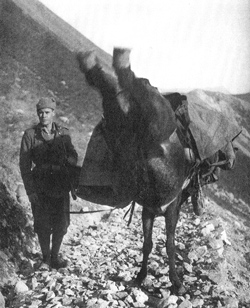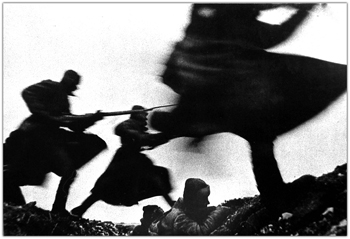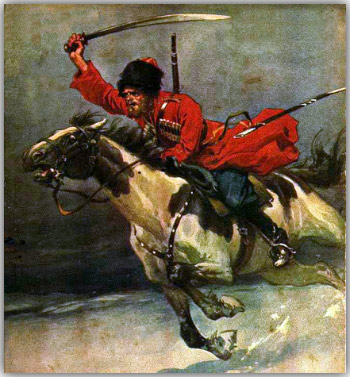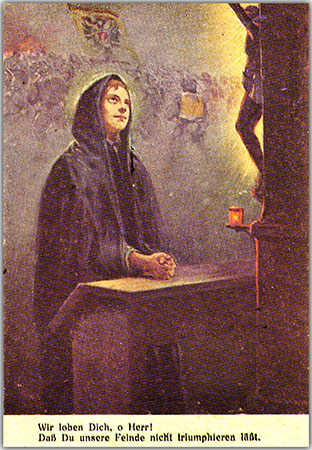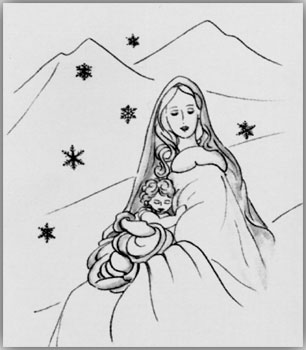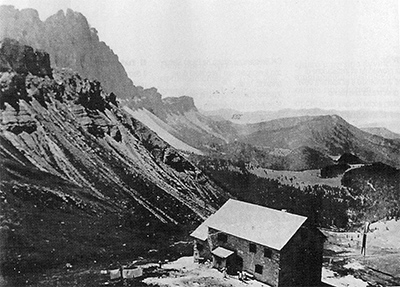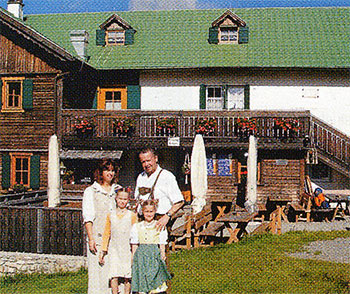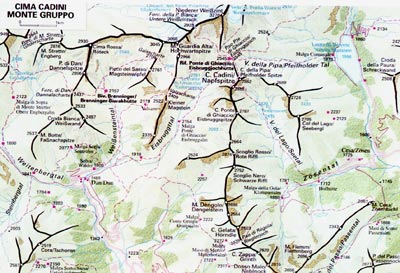|
"Soldato caduto"
Nessuno, forse sa più
perché sei sepolto lassù
nel camposanto sperduto
sull'alpe, soldato caduto.
Nessuno sa più chi tu sia,
soldato di fanteria,
coperto di erba e di terra,
vestito del saio di guerra,
l'elmetto sulle ventitre..
Nessuno ricorda perché,
posata la vanga, il badile
portando a tracolla il fucile
salivi sull'alpe... Salivi,
cantavi, e di piombo morivi;
ed altri morivan con te.
Ed ora sei tutto di Dio...
Il sole, la pioggia, l'oblio
t'han tolto anche il nome d'infronte.
Non sei che una Croce sul monte
che dura nei turbini e tace,
custode di gloria e di pace.
Renzo Pezzani
|
|
 |
"Nikolajewka"
Un’alba che nell’anima del sole
aveva la speranza.
Per immensi pascoli di neve
sotto un cielo arato di morte
più volte sui tuoi dossi
si logorò l’audacia
a cercarvi la vita.
Solo al finire del giorno,
con disperato grido, epica schiera di fantasmi
passò tra mesto mormorio di preghiere.
Scende ora il sole sull’alto del crinale
bagnando di luce i tuoi morti
e, in un vento di nuvole, fugge
il tuo solitario pianto
verso cieli lontani.
Non più aspre terre e profili di monti
nei loro occhi di vetro
ma lunghe file mute di uomini
su sentieri di ghiaccio.
|
La pista si è fatta di stelle
e cristalli di luna si spengono
su misere croci senza nome.
Nelson Cenci
|
Se la storiografia militare è ricca di relazioni sugli organici delle Unità, sugli eventi bellici della "prima linea" e sulla loro interpretazione, più o meno obiettiva, non altrettanto è generosa nell'informarci su quanto avveniva nelle retrovie e nelle aree di schieramento dei supporti logistici.
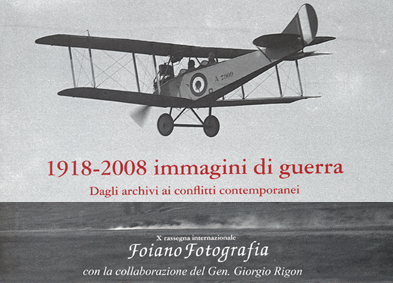 Copertina della monografia
Le fotografie dell'archivio "Furio Del Furia" di Fogliano della Chiana (Arezzo) (1) sono state scattate nel biennio 1916-1917, la raccolta conserva un nucleo di diverse provenienze coeve che suscita sorpresa e riveste particolare interesse poiché ci parla dell'aspetto meno conosciuto della realtà operativa della “Zona Carnia”: quello dell'ambiente umano e geo-topografico ove erano dislocate le unità tattico-logistiche più arretrate, destinate a sostenere gli sforzi difensivi ed offensivi di quelle schierate sulla displuviale delle Alpi Carniche, dal Monte Peralba al Monte Rombon.  Trattrici di artiglieria parcheggiate nell'area di una masseria. Il settore denominato "Zona Carnia", era presidiato da una Grande Unità non organica a livello Corpo d'Armata, strutturata su trentuno battaglioni, di cui ventiquattro Alpini, e supporti vari d'Artiglieria, Genio, Motorizzazione ecc., al comando del Generale Clemente Lequio. Detta zona costituiva anello di congiunzione tra la 4^ Armata del Cadore e la 2^ dell’Isonzo. L'interpretazione delle fotografie di quest'archivio consente, a noi lettori attenti, d'intraprendere un percorso di conoscenza inverso a quello della logica storiografica; infatti anziché condurre le nostre riflessioni iniziando dai fatti d'arme condotti dalle forze contrapposte sulla linea di contatto (displuviate delle Alpi), per concludere con qualche cenno sulla zona arretrata, siamo invitati a fare partire la lettura dalle immagini delle retrovie, per poi collegarci idealmente agli eventi più noti della prima linea.
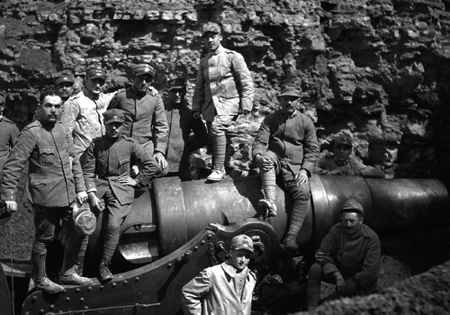 Affusto di artiglieria.
Sappiamo che l'organizzazione e l'attività logistica nella "Zona Carnia" fu un capolavoro di pianificazione che divenne modello anche le Forze Armate delle potenze alleate. In essa fu realizzata una fitta rete stradale ed alcune linee ferroviarie a scartamento ridotto (in particolare la ferrovia Carnia-Villa Santina) per le esigenze di rifornimento alle truppe avanzate, tutte schierate nelle zone più impervie delle Alpi Carniche.
 Laboratorio di minuto mantenimento.
La conferma di questa studiata operazione logistica ci viene anche da alcune fotografie che riprendono la poderosa galleria paravalanghe realizzata in corrispondenza del Passo della Morte (alta Valle Tagliamento) e dalle molte fotografie che raffigurano soldati, attrezzature del Genio, autoreparti e unità trattrici d’artiglieria, accantonati presso masserie nell'Alta Valle Tagliamento e nella valli del Degano, del But e del Fella.  la galleria del Passo della Morte, Alta Valle Tagliamento.
|
L'aspetto singolare di queste immagini è che, nelle aree rurali requisite e ristrutturate in funzione delle esigenze dei diversi reparti, i militari e le famiglie dei montanari hanno continuato a convivere in buona armonia, come testimoniano le numerose fotografie di ufficiali e soldati che cavalcano quadrupedi e motociclette di proprietà dei loro civili ospiti, essi pure fotografati amichevolmente. 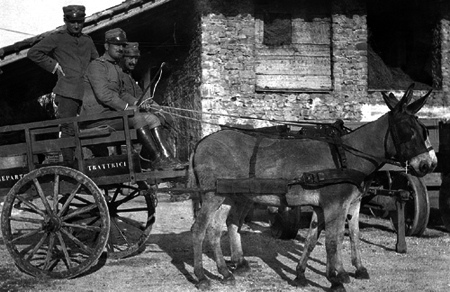 Carretta leggera del Reparto Trattrici.
 Ufficiali del Reparto Genio.
Appare, inoltre, che diversi aerei leggeri da ricognizione figurano, con il loro pilota, su piste d'atterraggio occasionali e speditive, sottratte temporaneamente all'agricoltura ed alla pastorizia locale. Non vi furono evacuazioni, né profughi fino all'autunno del `17, quando la rotta di Caporetto costrinse tutti all’esodo.
 Scafi del Genio Pontieri per ponti di barche.
Il nostro pensiero va ai caposaldi avanzati ai quali una siffatta organizzazione doveva garantire la costante e tempestiva catena dei rifornimenti. Lassù, oltre i duemila metri dei monti Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel, difesi, persi e riconquistati tra il 1915 ed il 1917 dagli Alpini, dai Fanti e dalle Guardie di Finanza, dovevano arrivare armi, munizioni e viveri e, laddove non arrivavano i mezzi meccanici, le salmerie e le teleferiche, intervenivano le mille Portatrici Carniche, volontarie, generose e forti donne delle tre valli che, sull'esempio dell'eroica Maria Plozner Mentil, si erano riunite in un Corpo di Ausiliarie, garantendo quotidianamente rifornimenti e conforto morale ai combattenti della prima linea.
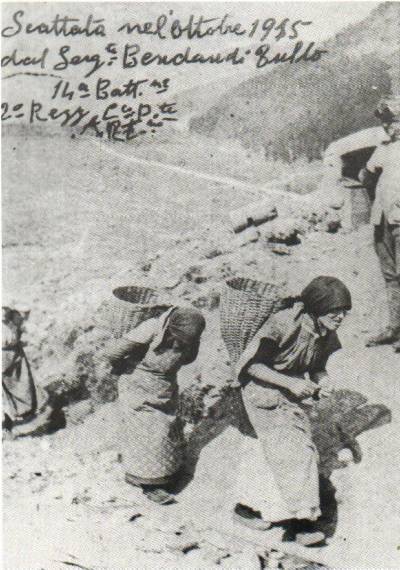 Portatrici carniche.
Allorquando, dalla lettura di semplici fotoricordo, scaturisce lo stimolo a proiettarci idealmente verso le zone calde del fronte ed agli episodi più eroici delle vicenda patria, vuol dire che l'opera fotografica trascende il valore privato per assumere valenza storiografica.
Bressanone, maggio 2008
(1) Le fotografie che illustrano questa breve evocazione storica sono tratte dall'Archivio del Comune di Foiano della Chiana (AR), (ad eccezione di quella dedicata alle Portatrici Carniche che fa parte di un archivio privato), e sono pubblicate nel volume "1918-2008 immagini di guerra dagli archivi ai conflitti contemporanei", ed. 2008, Città di Castello (PG).
|
 |
"Dove sei stato mio bell’alpino..."
Giulio Bedeschi, l’autore di «Centomila gavette di ghiaccio», rievoca le origini e la storia dei canti degli alpini ed alcuni dei più famosi episodi di guerra legati a questi canti. In essi rivivono la dolcezza, l'umiltà e l’orgoglio dei nostri soldati della montagna.
Quando si parla di “canzoni degli Alpini” non si vuole affermare che queste siano tutte nate dopo la costituzione del Corpo degli Alpini e che rappresentino un esclusivo patrimonio di questi soldati. Essendo manifestazione d’arte popolare, tali canzoni affondano le loro radici e le loro provenienze in un patrimonio popolare che si perde addirittura nei secoli passati.
Diverse canzoni schiettamente ed esclusivamente alpine sono sì nate negli ultimi decenni, ma è doveroso dire che alcune altre, anche fra le più note, s’inseriscono nel grande quadro delle manifestazioni canore corali che, risalendo attraverso le vicende storiche nazionali e rimontando addirittura i secoli, finiscono col perdersi nelle penombre del medio evo.
Volendo tralasciare i canti funebri per gli eroi caduti, in Omero, è presumibile che in ogni esercito del tempo antico sorgessero spontaneamente dei canti; è storicamente dimostrato che alcuni canti militari hanno lasciato traccia di sé dai tempi delle Crociate. Successivamente, soprattutto i Francesi durante le loro scorribande armate attraverso l’Europa, diffusero i loro canti di guerra. In Italia, il Piemonte, più a diretto contatto con la Francia, fu il primo ad assimilare e diffondere tali canti, naturalmente apportando subito modifiche linguistiche e melodiche in ciò che il patrimonio francese appariva più suggestivo e adattabile al gusto popolaresco padano.
Già nel 1630, durante la guerra dei Trent’Anni i reparti savoiardi e valdesi che, sotto il comando di Carlo Emanuele I, in alleanza con l’esercito imperiale austriaco, assediavano la città di Mantova occupata dai Francesi, nelle remore dell’assedio ebbero occasione d’imparare e diffondere un canto francese sorto tra le truppe di Francesco I in occasione della presa di Torino nel 1536. Questo canto, assieme ad altri nati spontaneamente fra le truppe piemontesi, venne tramandato e rielaborato per un intero secolo, e ne resta ancor oggi ricordo nel repertorio valdese.
Il Re di Sardegna Carlo Emanuele III costituì le “milizie delle valli” di reclutamento piemontese, che costituirono il nerbo dell’esercito sardo e si possono considerare i diretti ascendenti dei nostri Alpini. Queste truppe, giungendo dalle diverse zone di reclutamento, diffusero i tipici canti dei loro paesi di provenienza originando i primi confronti e i primi adattamenti. Nacquero così i canti di reparto e si diffusero presso altri reparti, con le usanze di ritmare col canto le marce o di interrompere con qualche canzone il lento trascorrere delle ore di riposo.
Già allora nei reggimenti composto quasi totalmente da popolazioni subalpine i canti non nascevano improntati a gloriose esaltazioni di imprese guerresche, ma preferivano mantenere uno stile privo di retorica, impostato su temi più semplici e quasi rozzi riguardanti le fatiche della vita militare, le contrarietà imposte dalla disciplina, il noioso ripetersi delle esercitazioni, indulgendo tutt’al più, a qualche arguto e piccante accento ad amori ancillari o a qualche allegra sosta in osteria. Ciò in contrasto con l’esplodere delle altre canzoni ottocentesche italiane che caratterizzarono la vena patriottica ispirata dalle imprese garibaldine e che i volontari di Garibaldi diffusero nelle file dell’esercito sardo, quando vi furono inseriti dopo la costituzione del Regno d’Italia.
Avvenne. Così, che qualunque sia stata la provenienza degli uomini incorporati nell’esercito sardo, essi assimilarono e accettarono le canzoni piemontesi e ne divennero i cantori e i diffusori, tralasciando il retaggio canoro paesano, ancor vivo nelle loro zone di provenienza. A conferma di ciò il Nicolosi, in un saggio del 1907 intitolato “Canzoni militari”, scriverà: “È strano ma è così. Non un ritmo, non una poesia che non abbia ricevuto l’impronta, quasi la imposizione, da quel rude Piemonte”.
Ma all’espansione di questo predominio piemontese nei canti militari posero argine, con l’annessione del 1866, le tradizioni e lo spirito delle popolazioni venete che, grado a grado, col loro apporto di giovani soldati fecero affiancare al rozzo vigore del canto militare piemontese quella vena di dolcezza temperata di malinconia che si alterna ad esplosioni di effusa allegria e di consapevole umile orgoglio, caratteristica delle genti venete e carniche. Esistevano in proposito, da almeno un secolo, chiari esempi di autonoma ispirazione:
Eran ginti al crudo passo
Nove milia e più germani;
avean preso il monte, i vani;
ma cazàti fuori a basso
da quaranta di Venzone.
…….
Su, fedeli e bon furlani,
fate che ‘l mondo risone
di gridar Venzon, Venzone!
Nei nuovi canti, pertanto, si individuano già le tracce della tendenza al confluire dello stile del canto popolare militare piemontese, per lo più orientato ai motivi di vita di caserma, con lo stile vneto-friulano, ricco di un suo apporto costituito da una più precisa e ingentilita individualità e umanità. Questa fusione rappresenta il germe e i l preludio alla nascita delle canzoni tipicamente alpine, che soltanto nelle trincee della guerra ’15-’18 troveranno i motivi per amalgamare i più diversi elementi di ispirazione tratti da un piano ormai nazionale con le ragioni contingenti determinate da una guerra di posizione durata per anni.
Infatti, a parte la riesumazione di due o tre canti alpini che ci vengono tramandati dal tempo della battaglia di Adua (Baldissera manda a dire / che il nemico è sui confini / c’è bisogno degli Alpini / per poterli liberar) e la diffusione anteriore al 1915 di alcune canzoni che non scompariranno più dal repertorio (“Oi barcarol del Brenta”, “E c’eran tre Alpini”, “Nui suma Alpin”, “Sul cappello”) , è nel corso della vicenda nazionale che ha per ambiente il teatro della grande guerra e per movente la passione e il dolore dell’intero popolo italiano, che dalle generiche e particolari provenienze folkloristiche, regionali, dialettali montanare e popolaresche, iniziano ad isolarsi chiaramente le canzoni militari dei soldati che stanno “facendo la guerra”; e fra queste si possono individuare per una particolare loro fisionomia le “canzoni degli Alpini” che da allora in poi costituiranno e perpetueranno una vera e propria massiccia tradizione.
Come in ogni altro reparto, non è certamente fra i fischi delle pallottole e l’infuriare delle cannonate che nascono i canti alpini, ma piuttosto nelle pause della battaglia, dopo che i superstiti hanno ripreso respiro, si sono contati, hanno raccolto i feriti e recuperato i morto, li hanno avviati a valle, o sepolti; quando, infine, mancando di acqua e per non lasciare traccia soffregano a lungo con una manciata di terra le mani sporche di sangue, estraggono poi di tasca la lettera già iniziata da giorni e decidono di completarla finalmente, aggiungendo alla nuova data: cara moglie, anche oggi sono vivo.
È proprio in quei momenti che la matita resta ferma tra le labbra, e is soldati fissano un tratto indistinto nel cielo e subito si perdono nella visione della famiglia lontana, ritornano ai minuti degli ultimi addii dal treno in partenza, rammentano i vagoni traboccanti di soldati che cantano perché ormai nel canto resta l’unico modo d’affermare le struggente voglia di vivere.
E ora si guardano attorno, osservano la miseria e lo sporco della trincea, fissano gli elmetti ammaccati e i cappotti fangosi dei compagni rimasti sempre in meno, accovacciati lì presso, i loro volti barbuti e inselvatichiti, ma ormai tanto cari, fraterni. Ed è allora che un nodo alla gola costringe il respiro, pare contrastare per un sentore di intima rampogna o disagio il gesto della mano che tuttavia scende sul foglietto disteso sul ginocchio e traccia a fatica le parole: vcara moglie sono vivo.
È l’ora, questa, è l’atmosfera in cui nascono le canzoni. Su un pezzo di carta, su una cartolina in franchigia, ne retro di una busta usata. Senza pentagramma, certamente. Senza nozioni di poesia, nemmeno di sintassi. Basta una matita, e il cuore. Per una che resterà poi nel tempo individuata come “canzone d’autore” , sono decine e decine quelle nate senza alcuna paternità, composte da un inconscio poeta o generate dalla patetica buona volontà di un gruppetto di Alpini seduti vicini a prender fiato in una qualche baracchetta, pronti ad aiutarsi reciprocamente anche in questa disperante lotta – grammatica contro sentimento – consultandosi con gli occhi e cercando le parole, mentre si attende di montare il nuovo turno di guardia. Sulla linea delle parole si tentano i primi acceni della melodia, che si snoda e si torce a poco a poco si compone, ripetuta con umiltà e con perseveranza, fino a quando succede che quel gruppetto di altri Alpini meno distanti drizza le orecchie, ascolta con diffidente silenzio, poi accenna a un “sì” e si alza infine lentamente per accostarsi e aggiungersi agli intimiditi cantori. Esce di tasca una fisarmonica da bocca, cerca a tentoni il motivo, gli altri seguono e ripetono, si scambiano i primi consensi soddisfatti:
- La va. La va.
- A mi la me par bona.
- Mi scomé to che la ‘tàca!
- Sperémo, ciò, dopo tuta ‘sta fadìga!
Nasce così, come germina da un cespo d’erba sulla roccia una stella alpina o una campanula, una nuova canzone per la compagnia, forse per il battaglione, forse per tutti gli Alpini.
“Bombardano Cortina…”,
“Di qua, di la dal Piave…”,
“Dove sei stato mio bell’Alpino…”,
“Eravamo in ventinove…”,
“Monte Canino…”,
“Monte Cauriol!…”,
“Montenero…”,
“Sul ponte di Bassano…”.
Più tardi, durante gli anni di pace, nasceranno le discussioni e le distinzioni colte e sottili, a volte addirittura accanite, per decidere se le canzoni degli Alpini costituiscono fatto d’arte e come vadano inserite, con dettagli e sofisticherie, nel patrimonio culturale italiano.
Sta di fatto che gli Alpini non hanno mai cercato di farsi avanti e inserirsi nelle categorie dei canterini con presunzioni artistiche, ma in ogni tempo della loro storia si limitano a canatre dapprima per sé stessi , per una propria intima soddisfazione, e ciò può avvenire nelle condizioni più disparate in tempo di guerra come in tempo di pace. Per essi via via il motivo di cantare può essere l’allacciarsi a un ricordo lieto o triste, o l’evocazione dei compagni scomparsi, o un’affermazione d’orgoglio che non si sa né si vorrebbe diversamente esprimere, o una esplosione di vitalità e d’allegria, o un aiuto a sé stessi per ritmare il passo quando la marcia è diventata ormai troppo lunga ed estenuante; o, infine e soprattutto, è un mezzo sincero e immediato per riconoscersi, un contrassegno e un sigillo che lega in un vincolo canoro e, fondendo ogni voce, crea senso di massa e di vigore.
Non c’è vanità, non c’è millanteria nel canto degli Alpini, molte loro canzoni possono essere cantate durante una cerimonia religiosa – “Stelutis alpinis”, “Bandiera nera” -;a, si sa, vale per essere canticchiata facendo brusca e striglia, o per far sorridere i vecchiotti e la ragazzetta che porta il mezzo litro nelle osteriole dei villaggi:
“Il ventinove luglio…”
“Nui suma Alpin, am piase el vin…”.
Però, a considerare nel loro insieme i canti degli alpini, a collocarli nella progressione del tempo e delle patrie vicende, a collegarli con la storia dei battaglioni e dei reggimenti, con le pietre e con le nevi, con le caverne e le cengie e le morene fra le quali presero vita, allora sotto la semplice linea melodica scorre una vena segreta che sa di offerta, di dolore, di sacrificio, di taciturna coscienza di un dovere sempre adempiuto, di un amore geloso e tenace che ha fatto da trama alla storia d’Italia, e che, lasciando scomparire il volto di ogni singolo alpino (il canto corale è prima di tutto espressione di disciplina e di umiltà), innalza la storia degli Alpini verso gli approdi della leggenda e dell’epopea. Chiedendoci perché gli alpini cantano in quel modo, si potrebbe affermare che gli alpini cantano così per la stessa ragione per la quale così hanno sempre saputo vivere e resistere fino a morire: con quel loro inimitabile, semplice modo d’essere uomini.
Non si vuol dire che i canti più belli e significativi siano quelli degli Alpini.
Nella storia dei canti militari italiani esiste una naturale, scambievole offerta di canti da reparto a reparto e un continua adattamento conseguente; ed è facile immaginare come un portaordini ciclista, o i conducenti di una corvée, avendo fissato nei timpani un nuovo simpatico motivo colto fra le baracche di un accantonamento di Alpini, l’abbiano poi riportato tra i fanti o gli artiglieri, magari già deformato in qualche sua parte.
|
O viceversa. Talché, in questi ultimi anni, per rimettere un po’ d’ordine nell’ormai ingente patrimonio delle canzoni militari italiane e poter individuare, fra tutte, quelle nate sicuramente da matrice alpina, la Associazione Nazionale Alpini ha indetto a Lecco nel 1965 un “Convegno in difesa del canto alpino”.
A conclusione di tale convegno è costituita una commissione di esperti che ha compilato una raccolta «Canti degli Alpini» edita nel 1967 a cura della Associazione Nazionale Alpini.
In essa sono stati riuniti, e riportati, dopo appassionate ricerche e disamine, la linea melodica e i testi ritenuti sicuramente originali ed autentici.
Tale selezione non ha costituito impresa da poco, essendo stato necessario rifarsi a vecchie documentazioni storiche e a minutissime e talvolta discordi testimonianze da confrontare e vaglia re per giungere a conclusione certa.
Ne è venuto un elenco dì trentuno canzoni di sicura nascita alpina, senza escludere la possibilità che più approfondite ricerche possano aumentarne il numero, e con la speranza che la vena popolare alpina allarghi nel tempo il canzoniere.
Si è inteso, così, dare una traccia sicura e fissa che rimanga costante matrice a salvaguardia di un patrimonio artistico quanto mai labile, quale può essere la canzone popolare, soggetta a infinite variazioni e interferenze, determinate dalle circostanze e dal mutare dei tempi. Tale intento non si riferisce soltanto alla legittima aspirazione dei “veci” Alpini di tramandare alle giovani leve una integra tradizione canora, ma si rivolge anche alle innumerevoli formazioni corali che in tutta Italia tengono VIVO il culto del canto di montagna.
Fino alla seconda guerra mondiale l’interesse per il canto alpino era per lo più circoscritto nell’ambito delle «penne nere» durante il periodo di servizio militare, e ai naturali luoghi di provenienza di tali soldati, le valli alpine le regioni subalpine; dall’ultimo dopoguerra in poi invece il “boom” della meccanizzazione, con la diffusione di dischi, radio, televisione, ha investito anche il campo della canzone alpina, diffondendola anche in ambienti fino allora scarsamente o per nulla interessati. Ne è sorta la inevitabile conseguenza che la primitiva linea melodica monodica sia stata spesso non soltanto alterata, ma assoggettata a trattamenti più vari, agli arrangiamenti e alle armonizzazioni più disparate, dalle quali traspare senz’altro in primo luogo una sempre rinnovata passione per il canto covale alpino. ma dalle quali, tuttavia si può a volte anche notare qualche eccessiva concessione ai gusti musicali d’oggi; cosa che non manca di determinare impennate e
giuste prese di posizione fra i molti gelosi custodi del canto alpino tradizionale.
Per controverso, in opposizione di orientamenti, contro chi vuole mantenersi rigidamente aderente alle autentiche fonti, sta chi invece è più corrivo a cercare nuove varietà di espressione, ritenendo di restare ugualmente inserito nel naturale fluire della corrente del canto alpino.
Tralasciando ogni disquisizione e giudizio estetico, ciò che in definitiva è sostanziale è il perpetuarsi spontaneo della validità e autenticità di una tradizione grazie alla quale sempre si rinnova, anche nella diversità dei tempi, la inimitabile episodica che vincola il canto alla stessa vita degli Alpini, e ne costituisce parte integrante.
Canta, così, oggi, l’Alpino. mentre nella sua camerata sta riassestandosi la branda, come cantava l’alpino nel 1917, quando, giunto a riposo nel fondo valle si inginocchiava fra i sassi del torrente a lavarsi allegramente maglia e mutande; come cantava in egual modo, in una continuità di impostazione sentimentale e morale che non conosce diversità di condizioni o di tempi, l’intera compagnia di Alpini del Battaglione “Val Chisone” comandata dal Capitano Martini, alla quale è giusto dedicare qui un ricordo, nel cinquantenario.
La compagnia era da mesi dislocata a ridosso delle Tofane, arroccata sulle rocce del Piccolo Lagazuoi, a sentinella del Passo Falzarego, appigliata a quota 2500 metri e abbarbicata lungo una aerea cengia a sbalzo sul vuoto digradante verso la Val Parola e chiamata appunto “Cengia Martini”. Posizione pazzesca a viverci. ma di prim’ordine a saperla tenere, dominante com’era; sempre contesa dagli austriaci, che a un certo punto iniziarono a scavare una galleria muovendo dalle loro posizioni sottostanti, e con settimane di lavoro da talpe si portarono a raggiungere la cengia, nell’intento dì occuparla di sorpresa facendo saltare una mina e aggredendo subito gli Alpini frastornati o tramortiti.
Ma i rumori di scavo non erano sfuggiti agli Alpini che, sommando i vari i indizi, avevano intuito l’intento e avevano controllato il progredire dei lavori fino al giorno in cui, giunti gli Austrici ormai sotto la cengia, gli Alpini di guardia individuarono il punto ove si stava ammassando l’esplosivo. Fu allora che il capitano Martini ottenne di far salire dalla valle, con trombe e tromboni, alcuni elementi della fanfara reggimentale, che si appostarono con gli alpini nei pressi del punto ove sarebbe esplosa
La mina. Cosicché, quando questa fu fatta brillare e gli austriaci si gettarono nel varco ancora fumigante per irrompere alla conquista della posizione italiana, si trovarono aggrediti dall’esplodere dello strombettare dei soutatori che a tutto fiato rinforzavano le voci degli Alpini, i quali in frenetico coro avevano attaccato una tra le più allegre e aggressive delle loro canzoni. Sotto lo sferzare delle note che sottolineavano il fallimento della sorpresa e la scanzonata sicumera degli Alpini, gli sbalorditi austriaci ripiegarono rapidamente quatti quatti alle posizioni di partenza.
Allegria, orgoglio, malinconia, nostalgia si alternano e sifondono quindi secondo l’ora, l’estro e gli eventi, nella canzone che gli alpini di volta in volta cantano. Sono lontane, talora irraggiungibili e sconosciute, le vene d’ispirazione originaria; affondano nel terreno della nostra storia spesso in modo imprevedibile e riaffiorano di tempo in tempo quando un nuovo estro o un nuovo dolore le richiama, le ritrasforma adattandole a un nuovo tempo, a una nuova necessità di canto. A volte sono vecchie parole che si vestono di una nuova melodia. A volte è un vecchio motivo che si stende su nuovi versi, convulsi e dolorosi, quasi a placarne la concitata voce di sofferenza. A indicare, anche nella vita degli alpini, la ineluttabile continuità della sofferenza umana, mai disgiunta dalla grandezza d’animo di chi sa sopportarla tanto da trasformarla in virtù.
Un esempio forse ineguagliabile di questa continuità è dato appunto da una fra le più conosciute ed amate canzoni alpine: « Il testamento del Capitano ».
La storia di questa canzone comincia da molto lontano, da quando nel 1528 morì in combattimento nel napoletano il marchese Michele Antonio di Saluzzo, e fra i suoi soldati nacque una prima versione conosciuta appunto come “Testamento del Marchese di Saluzzo”.
Già Costantino Nigra, nel 1888, nella sua raccolta « Canti popolari del Piemonte » ne ripete il testo (una part mandéla in Franza). Tale canzone trovò diffusione, con molte varianti e innumerevoli adattamenti, specialmente nel Trentino. Nella prima guerra mondiale gli alpini tradussero definitivamente il testo dal vecchio dialetto piemontese in lingua italiana, temperata dalle loro caratteristiche licenze di gergo montanaresco:
Il capitan della compagnia
e l’è ferito, sta per morir
e manda a dire ai suoi Alpini
perché lo vengano a ritrovar.
I suoi Alpini ghe manda a dire
che non han scarpe per camminar.
O con le scarpe o senza scarpe
i miei Alpini li voglio qua.
Tale canzone, patetica quante altre mai e ricca di grande suggestione, durante la prima guerra mondiale ebbe una diffusione forse incomparabile, e rimase impressa nell’animo degli italiani fino al giorno d’oggi.
È stato rilevato e affermato che durante la prima guerra mondiale nacquero e si diffusero molte canzoni militari, alpine o d’altri corpi e armi, e che invece anche a questo effetto la seconda guerra mondiale fu pressoché sterile. Senza voler approfondire in questa sede le cause di tale fenomeno, è giusto tuttavia rendere nota una eccezione che dimostra come anche nell’ultima guerra l’animo alpino, sollecitato da appassionati vincoli e da opportune condizioni seppe esprimere ancora una volta qualcosa di profondo e di duraturo: non creò una nuova melodia (e ciò può avere un suo significato), ma preferì adattare il morivo melodico de «Il Testamento del Capitano » a un testo composto da un gruppo di alpini del 7° Reggimento per esprimere il loro dolore allorché il loro Comandante, Colonnello Rodolfo Psaro, cadde in Albania nel dicembre 1940, combattendo alla loro testa.
Tale canto, anche se gli eventi di guerra e poi di pace non ne hanno favorito la diffusione, per il suo valore poetico e per la sua eccezionale immediatezza espressiva vale a testimoniare quella permanenza di sentimento e di forza virile che hanno collegato direttamente l’animo degli alpini del nostro tempo al perenne spirito della tradizione alpina:
il Colonnello fa l’adunata
negli occhi tutti el ne gà vardà,
e poi ha dctto ai veci Alpini
di tener duro n’ha comandà.
I suoi Alpini ghe fa risposta
“Sior Colonnello se tegnerà”
e scarpinando su le montagne
in prima linea i s’à portà.
E per do mesi i à tegnù duro
In mezzo al freddo da far giassar,
scoltando sempre le sue parole,
“sacrificarsi ma non mollar”.
E i suoi Alpini gli manda a dire
Che non gli riva né pan né vin.
E il Colonnello gli fa risposta,
“Questo l’è niente pe’ i veci Alpin”.
E i suoi Alpini gli manda a dire
Che i non gà scarpe per camminar.
E il Colonnello gli fa risposta,
“No serve scarpe per restar là”.
E un altro mese sti veci Alpini
Gà tegnù duro senza mollar
Ed ogni giorno i greci tacava
Senza esser boni mai de passar.
E i suoi Alpini gli manda a dire
Che massa pochi son restà
E il Colonnello va su da loro
“Niente paura, eccomi qua”.
E la matina se leva il sole
E le montagne el gà indorà.
Il Colonnello co’ i veci Alpini,
tutti era morti, ma i era là.
Ecco i titoli dei trentun canti considerati degli Alpini perché nati, quasi per germinazione spontanea, tra le truppe alpine:
: A la matin bonura; Aprite le porte; Bandiera nera (Sul Ponte dì Perati); Bersagliere ha cen¬to penne; Bombardano Cortina; Di qua, di là del Piave; Dove sei stato mio bell’Alpino; E Cadorna manda a dire; E c’erano tre Alpin; E la nave s’accosta pian piano; Era una notte che pioveva; Eravamo in ventinove; E sul Cervino; E tu Austria; il testamento del Capitano; Il Colon¬nello fa l’adunata; Il ventinove luglio; La Linda la va al fosso; Man/¬ma mia vienimi incontro; Monte Ca-nino; Monte Cauriol; Montenero; Motorizzati a pié; Nui suma Alpin; Oi barcarol del Brenta; Oi cara mama; SulcCappello; Sul ponte di Bassano; Ti ricordi la sera dei baci; Trenta sold; Va l’Alpin.
Giulio Bedeschi
|
 |
"Astuzie di conducenti e maniscalchi"
Premessa.
La cronaca che segue è tratta da: Storia del Gruppo artiglieria da montagna "Val Tanaro", monografia del Gen. C.A. Giovanni Delfino, ricca di cronache e racconti autobiografici incentrati sulla minore unità in cui l'Ufficiale ha iniziato la carriera , proseguendola nella stessa unità come comandante di batteria durante la Seconda Guerra Mondiale sul Fronte Alpino Occidentale e sul Fronte Greco-Albanese.
In questa sede, ci proponiamo di pubblicare anche altre parti significative del saggio di Giovanni Delfino, fino al capitolo conclusivo, ricco di riflessioni di grande valore morale e di afflato religioso.
Il seguente racconto è ambientato a Entracque (CN), ove la 26^ btr. "Val Tanaro", nell'anno 1939, era in approntamento in vista del successivo schieramento sul Fronte Alpino Occidentale.
Il racconto.
Voglio qui ricordare un episodio piuttosto banale, ma significativo per dimostrare quanto fu difficile realizzare un buon amalgama fra i comandanti dei vari reparti, specie tra quelli che, essendo stati richiamati in servizio dopo molti anni dal loro congedamento (alcuni si trovarono a essere richiamati con il grado di Capitano, mentre erano stati congedati con quello di Sottotenente), non avevano potuto, in breve tempo, stabilire reciproci rapporti di confidenza e cameratismo.
Un giorno, rientrati verso sera da un’esercitazione piuttosto faticosa, distribuito il rancio ed eseguiti i soliti controlli, mi ero ritirato nella mia tenda, allorché il responsabile della “guardia scuderia” mi venne ad annunciare che al filare mancava un mulo.
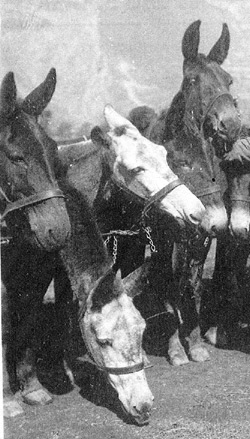 Ph. Giovanni Delfino - ottobre 1939Gli dissi di vedere se per caso si fosse sciolto e si fosse recato a pascolare nei prati circostanti (talvolta accadeva), aggiunsi che non mi venisse più a riferire, se prima non avesse trovato l’animale.
Ritornò dopo qualche tempo e mi assicurò che il mulo era di nuovo al suo posto.
Trascorsero due o tre giorni e un bel mattino, rientrata la batteria da un’esercitazione di “presa di posizione”, al momento del comando “scaricate i muli”, vidi spuntare ai margini dello schieramento le “lucerne” grigie di tre o quattro carabinieri; sorpreso, sospesi l’operazione in corso e chiesi al loro graduato (mi sembra fosse un brigadiere) che cosa stesse accadendo. Mi riferì che aveva avuto l’ordine di controllare se tra i muli della batteria ve ne fosse uno della 25^, mancante da un paio di giorni. Mi precisò che il comandante di quest'ultima era venuto a sapere che io personalmente avevo organizzato una squadra per rimpiazzare un mulo disperso durante un’esercitazione, andandolo a prelevare dal filare della vicina batteria.
|
Mi ricordai di quanto era avvenuto quella notte e, tranquillo, ordinai di agevolarlo nel controllo, che effettuò insieme al conducente della 25^.
Vi lascio immaginare l’espressione del mio viso, quando mi vidi condurre un mulo, che sullo zoccolo anteriore portava un numero di matricola malamente impresso di recente, a nascondere il vecchio numero.
Era chiaro ormai l’accaduto: i responsabili della “guardia scuderia”, d’accordo con il conducente del mulo che sembrava svanito nel nulla, avevano progettato l’incursione nella batteria più vicina, per prelevarvi un mulo simile, per mantello e corporatura, al “disertore”; avevano poi coinvolto il maniscalco di batteria, per modificare la matricola.
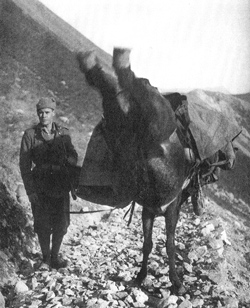 Ph. Giovanni Delfino - ottobre 1939
Dall’inchiesta svolta venni a sapere che, di quel bel gesto, gli autori si erano vantati con altri artiglieri del Gruppo, in un’osteria del paese, inventando la storiella che appioppava a me l’iniziativa.
La faccenda si faceva seria: il comandante della 25^, anziché informarmi subito delle chiacchiere a lui giunte (e, in questo caso, la questione si sarebbe risolta subito tra noi, con adeguati provvedimenti disciplinari), aveva preferito chiamare in causa i carabinieri, creando un caso.. .da tribunale militare! Il Comandante del Gruppo, subito informato, convocò a rapporto i comandanti delle tre batterie (io sostituivo il Capitano Sabbatini, assente); il comandante della 25^ insisteva nell’accusarmi di aver organizzato il rapimento, io riferivo i fatti come li avevo ricostruiti e il comandante della 27” dichiarava candidamente che finalmente si poteva spiegare come mai nella sua batteria, da alcuni giorni, c’era un mulo in più!
Il Tenente Colonnello Negro, molto salomonicamente, concluse a un di presso così: “Dovrei adottare provvedimenti disciplinari a carico di tutti e tre: del comandante della 25^, per deficienza nel funzionamento della “guardia scuderia” e nel superiore controllo, al comandante della 26^, per non aver approfondito a sufficienza il fatto della sparizione di un mulo e del successivo facile ritrovamento, al comandante della 27^ per essersi accorto in ritardo che al proprio filare c’era un mulo in più! Visto come stanno realmente le cose, andate in pace e non se ne parli più!”
E, per fortuna non se ne parlò più, salvo le punizioni inflitte ai principali attori.
Giovanni Delfino
Bressanone, gennaio 2006
|
 |
"L'entusiasmo ed il rigore morale"
- In memoria del Gen. C.A. Giovanni Delfino -
Premessa.
Il Generale Delfino, scomparso a Bressanone il 5 luglio 2008, è stato il mio Comandante di Brigata alla "Julia" negli anni in cui ultimavo il mio periodo di comando di compagnia. La sua equilibrata azione di comando ed il suo rigore morale furono modello per tutti noi.
Nei decenni che seguirono, egli continuò ad onorarmi della sua stima ed amicizia. Negli ultimi anni della sua vita, volle collaborare alla redazione di questo sito, proponendo articoli, saggi storici, immagini che contribuirono a qualificarlo sensibilmente e che, ora, costuituiscono un importante archivio delle sue e delle nostre memorie. Giorgio Rigon
Bressanone, novembre 2008
 Giovanni Delfino - ottobre 1968
GIOVANNI DELFINO
-
Allievo del 114° corso dell’Accademia di Artiglieria e Genio (1932-1934) e, poi, della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio (1934-1936). Nell’estate del 1935 partecipò alle “grandi manovre” in Alto Adige, quale subalterno della 1OA batteria del Gruppo “Mondovi”.
-
Dal luglio 1936, in servizio di prima nomina quale sottocomandante della 17^ batteria I Gruppo “Udine” nel
3° Reggimento Artiglieria Alpina “Julia”, in Gorizia.
-
Dall’ottobre 1937, subalterno della 5^ batteria/gruppo “Mondovi” nel 4° Reggimento Artiglieria alpina “Cuneense” in Cuneo e successivamente Aiutante Maggiore in 2^ del gruppo “Pinerolo” in Savigliano.
-
Dal 14 agosto al 7 ottobre 1938, comandante della 9^ batteria/gruppo “Pinerolo” in Borgo S. Dalmazzo.
Dall’8 ottobre 1938 al 24 maggio 1939, comandante della 12^ batteria/gruppo “Mondovi” in Ceva.
-
Dal 25 agosto 1939, dall’l1 agosto 1941, comandante della 26^ batteria del Gruppo “Val Tanaro”, mobilitato e impiegato in operazioni di guerra sul fronte francese e su quello greco- albanese.
-
Dall’ agosto 1941 al 9 settembre 1943, in servizio presso l’Accademia di Artiglieria e Genio in Torino e in Lucca, quale comandante di plotone allievi e insegnante di geografia; successivamente, Aiutante Maggiore in 1^ dello stesso Istituto.
-
Dal 9 agosto 1943 al 25 aprile 1945 ha partecipato alla lotta di liberazione, inizialmente presso una formazione G.L. in zona di Cuneo e successivamente con l’Organizzazione “FRANCHI”- Sezione Aviolanci per il Piemonte, in Torino.
-
Dal 12 dicembre 1945 destinato Reggimento Artiglieria da Campagna “Mantova” quale comandante di batteria motorizzata e successivamente quale Aiutante Maggiore in l^ del reggimento.
-
Dall’ottobre 1948 al luglio 1951 ha frequentato il 2° corso di Stato Maggiore e poi assegnato al Comando della Brigata alpina “Tridentina” quale capo Sezione addestramento operazioni ed informazioni.
-
Dall’ottobre 1948 al luglio 1951 ha frequentato il 2° corso di Stato Maggiore e poi assegnato al Comando della Brigata alpina “Tridentina” quale capo Sezione addestramento operazioni ed informazioni.
-
Dall’ottobre 1954 al settembre 1955 ha comandato, in Dobbiaco, il Gruppo “Asiago”, del 2° Reggimento Artiglieria da Montagna.
-
Dall’ottobre 1955 al 31 agosto 1958 ha ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Brigata alpina “Tridentina”.
-
Dal 10 settembre 1958 al 31 agosto 1960 ha prestato servizio presso il Comando delle Forze Terrestri Sud Europa, quale Capo Sezione Guerra psicologica — atomica — batteriologica - chimica, Capo Ufficio Operazioni , Capo della Segreteria di Stato Maggiore.
|
|
-
Dal 10 settembre 1960 al 9 gennaio 1962 ha comandato il 3°Reggimento Artiglieria da Montagna della Brigata alpina “Julia” in Udine.
-
Dal 10 gennaio 1962 è stato destinato al Comando del V Corpo d’Armata, in Vittorio Veneto, quale Capo di Stato Maggiore.
-
Dal 10 ottobre 1967 al 31 agosto del 1969 ha comandato la Brigata alpina “Julia” in Udine.
-
Il 20 settembre 1969 ha assunto l’incarico di Vice Direttore dell’Ufficio Centrale per gli allestimenti militari delle tre Forze Annate presso il Ministero della Difesa. Promosso al grado di Generale di Divisione assunse l’incarico di Direttore Centrale dello stesso Ufficio.
-
Promosso Generale di Corpo d’Armata, il 23 marzo 1974 fu collocato, a domanda, in posizione ausiliaria.
BIBLIOGRAFIA
LA CAMPAGNA DI GRECIA — Stato Maggiore dell’Esercito — Ufficio Storico
STORIA DELLE TRUPPE ALPINE — Edito sotto gli auspici dell’Associazione Nazionale Alpini — Cavallotti Editore — Edizioni Landoni Milano.
Giacomo Fatuzzo — STORIA DELLA “JULIA” nella Campagna di Grecia — Edizioni Longanesi e C.
Aldo Rasero — ALPINI DELLA JULIA - Storia della «divisione miracolo» — Edizioni Mursia.
Il racconto che segue testimonia, assieme a tanti altri episodi da lui dedicati ai propri Artiglieri, come il Gen. Delfino tenesse in gran conto i rapporti umani tanto che, nel corso della sua lunga carriera, ha mantenuto con quanti erano stati alle proprie dipendenze contatti cordiali ed affettuosi e quanto la sua viva e lucida memoria gli abbia consentito di coltivarli per tutta la vita.
"Da conducente di muli ad Imprenditore".
"Tutto incominciò quando il veterinario, visitando un mulo, concluse che non era più curabile, perché aveva una profonda fiaccatura al garrese, andata in suppurazione e ne decretò l’abbattimento.
Il mulo era stato condotto alla visita dall’artigliere Igino Peruzzo, di Molare (AL), il quale mi chiese di lasciarlo nelle sue mani per qualche giorno, perché potesse curarlo a modo suo.
Poiché a me premeva moltissimo poter conservare in vita il maggior numero possibile di quadrupedi, acconsentii. Dopo qualche giorno il mulo, alla cui ferita Peruzzo aveva applicato degli impacchi d’erbe medicamentose da lui cercate e trovate nei boschi vicini, era in via di guarigione. E così accadde poi per tanti altri quadrupedi feriti; avevamo praticamente trovato in Peruzzo un ottimo sostituto del veterinario, sempre di difficile reperimento, stante la grande quantità delle richieste d’intervento.
Peruzzo mi raccontò di aver imparato a trovare e usare le erbe medicinali, quando da ragazzo, rimasto orfano di entrambi i genitori, incominciò a seguire come aiutante un vecchio del suo paese, che lo prese a ben volere e gli insegnò i suoi “segreti”.
Aggiungo che dopo la guerra, intorno agli anni 1952 — ‘54, andai a cercarlo a Molare, dove aveva impiantato un’erboristeria di prim’ordine e si era acquistato la fama di “guaritore”, con una clientela vastissima, proveniente da ogni parte d’Italia e anche dall’estero.
i raccontò che essendo arrivato al paese nel 1945, povero in canna, riprese la sua attività di raccoglitore d’erbe medicinali e incominciò a dedicarsi alla cura delle persone ammalate; il caso volle che gli conducessero un giovane, figlio di un professore dell’Università di Genova e sofferente di non so qual male, contro cui nulla avevano potuto diversi medici.
Con le sue erbe egli lo guarì e il professore di Genova divenne suo grande ammiratore e protettore; lo aiutò ad organizzare l’erboristeria e a perfezionarsi anche dal lato culturale.
Oggi, in provincia di Alessandria sono attive una mezza dozzina di erboristerie PERUZZO, gestite da suoi parenti; egli è deceduto qualche anno fa".
Giovanni Delfino
Bressanone, 2006
|
 |
"Il concetto di eroismo"
"Stereotipia di un sentimento".
Ognuno di noi ha acquisito un'idea simbolica dell'eroismo, fin dalla più giovane età, maturandone il concetto in modo soggettivo, attraverso esperienze personali ed eventi che la sorte gli ha riservato.
A fattore comune, tuttavia, sembra esserci un'idea di eroe che tutti condividiamo: vediamo l'uomo vocato ad un destino eroico come una creatura che esercita, durante la vita, atti di eroismo di graduale intensità fino a quello ultimo che corona l'esistenza, ne sanziona il valore e, di frequente, ne stabilisce il termine.
Personalmente, ho assimilato il concetto di eroismo, durante l'età scolare, in due tempi distinti.
Una primaria coscienza l’ho ricevuta quando la maestra ha letto e commentato la motivazione della Medaglia d'Oro al valore di Enrico Toti: il gesto disperato dell'Eroe di lanciare contro il nemico la stampella (strumento che, già di per sé, testimonia un precedente atto eroico), è scaturito da un impulso all’apice dell’esaltazione. L’atto, allora, mi apparve talmente nobile da indurmi a configurarmi l'eroismo come qualcosa che dovesse impegnare il corpo dell'Eroe in uno slancio in avanti, irruente, indifeso, risolutivo, non di un combattimento ma della propria vita, che viene spesa in un attimo, senza agonia, soffocando il dolore, in omaggio ad un ideale altissimo e con un grido di orgoglio.
Una seconda presa di coscienza dell'idea di eroismo la debbo ad un amico melomane che mi dette l’occasione di gustare un disco (78 giri) del celebre tenore Tamagno: la voce altissima del finale, espressa in modo continuato, senza gorgheggi, senza modulazioni in calando, veniva troncata di colpo, all'apice dell'emissione acuta; l'improvviso silenzio che seguiva lasciava intuire qualcosa di estremamente drammatico, ineluttabile, eroico.
Nella mia infanzia, ho sempre collegato la figura di Enrico Toti a quella di Tamagno, nel combinato dell’azione gestuale dell’uno e di quella sonora dell’altro che, insieme, rimandano agli stilemi retorici e teatrali dei monumenti ai caduti e delle immagini della guerra di movimento che qui ho selezionato.
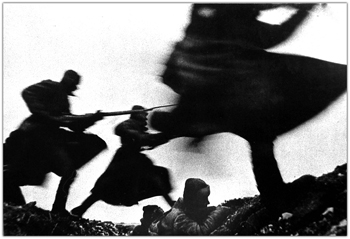
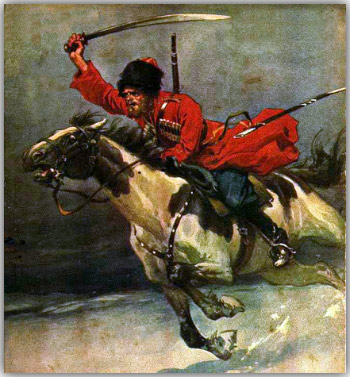 |
"Dio è con noi".
Non può esservi lotta tra avversari senza che sia invocata l’intercessione di un essere soprannaturale. La sacralizzazione del totem, d'altra parte, comporta di per sé che la divinità intervenga con la sua capacità di protezione o, quanto meno, con un segno d'incoraggiamento che quanto si fa nel suo nome è giusto e sacrosanto.
Coinvolgere gli Dei nelle guerre è sempre stata l'attività più importante dei condottieri, propedeutica ad ogni scontro d’armi, fin dai tempi di Omero, e questa si svolgeva con riti sacrificali del tipo di quello della povera Ifigenia.
Nelle tre religioni monoteiste le vittime sacrificali sono state più fortunate rispetto a quelle della mitologia greca: Isacco, infatti può ringraziare l'angelo che ha fermato la mano del padre Abramo.
Nella religione cristiana però non è bastato che il figlio di Dio abbia risolto il problema una volta per tutte sacrificando sé stesso in vista della salvezza di tutti: gli uomini continuano a chiamarlo in causa ed a metterlo in imbarazzo cercando di guadagnarne l’alleanza contro l’avversario.
Se gli eserciti contrapposti formulano le medesime invocazioni che vediamo riportate nelle due cartoline che appaiono qui sotto,
come si deve comportare Domine Iddio? Chi è dalla parte giusta? Chi beneficerà della provvidenza divina che, per favorire una parte, dovrà necessariamente intervenire a danno dell'altra? Forse è per questo che nel paradiso dei Caduti non ci sono né vincitori né vinti: tutti sono glorificati in virtù degli atti eroici espressi in nome di ideali nobili.
Giorgio Rigon
Bressanone, gennaio 2007
|
 |
"Quei grandi occhi innocenti dalle orecchie lunghe"(da:
Giuseppe Bruno, Storie di Alpini e di Muli, ed. L’ARCIERE, Cuneo, 1983)
PRESENTAZIONE.
Sembra non aver senso la pubblicazione di memorie belliche a distanza di tanti anni dai fatti raccontati; inoltre la nostra memorialistica sulla Seconda guerra mondiale è ricchissima di pubblicazioni, e, agli effetti della storia, i ricordi ritrovati molte volte possono distorcere la verità e creare non miti ma mistificazioni; e questo anche al di fuori delle intenzioni degli autori perché, come giustamente scrive Primo Levi, «La memoria è uno strumento meraviglioso ma fallace» e «I ricordi che giacciono in noi non sono incisi nella pietra; non solo tendono a cancellarsi con gli anni, ma spesso si modificano, o addirittura si accrescono, incorporando lineamenti estranei».
Questo però non è il caso del libro di Giuseppe Bruno, che è stato scritto non solamente ricordando ma costruito con gli appunti che l’Autore andava via via annotando nel momento che i fatti accadevano.
Chi racconta è stato ufficiale veterinario nei reparti alpini di artiglieria; dapprima sul Fronte occidentale, poi su quello Albanese-greco e, infine, sul Fronte russo; e chi in tale veste si è trovato coinvolto in tante funeste vicende belliche, può ben testimoniare l’ingrato e misconosciuto lavoro dei conducenti, e dirci come questi umili «sconci» o «drugiot» hanno moltissime volte determinato la salvezza di molti di noi che eravamo in prima linea.
In questo libro, dunque, si narrano vicende di uomini e di muli, ma è la prima volta, mi pare, che questi animali compaiono come personaggi nella nostra letteratura, e vi entrano di peso come giustamente meritano, sino dalle prime pagine con Tarcento, il mulo del conducente Giuseppe, che cade ammalato proprio il giorno della dichiarazione di guerra, il 10 giugno 1940. E subito entrando in questo mondo singolare e unico degli «sconci» arriviamo a capire, meglio che in altro modo, non solo gli errori più grossolani degli Alti Comandi, ma la nostra impreparazione, la superficialità, le deficienze logistiche a cui solamente l’inventiva, la forza morale, la resistenza fisica dei più umili, Uomini e Muli, appunto, hanno evitato maggiori disastri.
Accanto ai conducenti e ai muli troviamo, però, anche altri esseri che hanno accompagnato la nostra triste guerra, e ci voleva proprio un veterinario per raccontarlo, uno che con gli animali avesse dimestichezza; e gli episodi dei dodici cani randagi raccolti come «scaldapiedi» dagli artiglieri del Gruppo Bergamo, con la patetica storia di Antigelo, e poi quello della gara di corsa dei pidocchi, se possono provocare un senso d’ilarità, dicono anche quanto grama e drammatica fosse l’esistenza in quei tempi.
L’abbeverata nella nave prima dello sbarco a Durazzo, la storia di Bista e di Orvieto, i giorni fangosi dì Han, in Albania, l’osservazione della vecchietta russa al veder passare i «motorizzati a pié» con lo zaino affardellato («Sono prigionieri?»), basterebbero a dare a questo libro il merito d’essere stampato e di non far rimpiangere gli alberi che hanno fornito la carta. Ma è dove si demitizza e si riporta la verità che il racconto assume anche valore di testimonianza storica: sono bagliori che illuminano un buio che qualcuno non vorrebbe mai si discoprisse. E a questo proposito basterebbe citare l’assurdo ordine del generale Zingales che diceva di «rientrare immediatamente alle basi di partenza in quanto la situazione si era normalizzata », quando, in quel 16 gennaio 1943, tutto il fronte del Don era in ritirata e i carri armati russi scorrazzavano nelle nostre retrovie; oppure il colloquio molto animato tra S. E. il generale Gabriele Nasci, comandante del Corpo d’armata alpino, e il generale Reverberi, comandante della Tridentina, colloquio a cui il nostro ufficiale veterinario ha assistito, dove Reverberi rinfacciava a Nasci le « ventiquattro ore » che avrebbero potuto salvare la divisione Cuneense.
Questo e molte altre cose ho ritrovato nel libro di Giuseppe Bruno, come ho ritrovato gli amici lasciati sui monti dell’Albania e nelle steppe russe; il fango e il freddo; la fame e la disperazione ma anche l’amore e la fratellanza; e gli occhi dei muli: i grandi occhi pazienti e buoni di questi nostri compagni che con noi hanno diviso tutto, proprio tutto, e ci hanno permesso di sopravvivere quando il mondo crollava.
Mario Rigoni Stern
Il racconto.
Prima di entrare nel pieno dell’argomento muli in Albania mi si consenta di spendere quattro parole di presentazione dei quadrupedi in oggetto, a edificazione di quei miei benevoli lettori che conoscono i muli solo per averli visti qualche volta a sfacchinare attaccati ad una carretta o con un basto sulla groppa.
Il mulo (dal latino mulus) è sempre stato un infelice sin dalla nascita, o meglio, dal concepimento, in quanto è un ibrido e cioè un prodotto sterile nato dall’accoppiamento di due animali di specie diversa, nel nostro caso dall’unione di un asino con una cavalla. Un infelice non solo perché non può avere figli ma anche perché essendo un mulo e cioè animale solitamente testardo non è «un unto del Signore».
Avrebbero potuto portarlo alla ribalta, sotto un corteo volante di angeli osannanti, le Sacre Scritture, duemila anni fa. Ma quelle collocarono, invece nella Grotta di Betlemme e accanto ad un tranquillo bove, un tranquillissimo asinello. Ho l’impressione che neanche Gesù conobbe il mulo, tanto è vero che nel giorno delle Palme cavalcò un asino.
Esiste tra gli ibridi un animale più infelice del mulo: il bardotto. Questi è figlio di un cavallo e di un’asina. È più piccolo e meno robusto del mulo e non è né carne né pesce con quelle sue orecchie né lunghe né corte che non ricordano quelle del padre cavallo, che non ricordano quelle della madre asina. Ma il bardotto, a essere sinceri, se ne è sempre infischiato di questa sua evidente inferiorità fisica, tanto più che, salvo casi eccezionali, non è mai stato impiegato in guerra, e tanto meno in Albania.
Il cavallo è sempre stato l’animale «nobile» per antonomasia e personalmente io lo amo al pari del mulo e di ogni altro animale e ciò per una precisa scelta di etica comparata, al di là della accettata deontologia professionale. Ma per il mulo ho sempre avuto più comprensione non solo perché anch’io come lui non discendo da magnanimi lombi ma da decine e decine di generazioni di servi della gleba, non solo perché da ragazzino gli scarpinai accanto nei lavori dei campi, non solo perché fu, in seguito uno dei ‘miei più rassegnati pazienti nel mio primo periodo di inesperto veterinario civile, che svolgeva la sua attività in plaghe montane, ma anche e soprattutto perché fu proprio un mulo che segnò a caratteri indelebili il mio primo contatto con la vita militare. E fu un impatto doloroso e con tutti gli insegnamenti che scaturiscono da un dolore intensamente sofferto.
Il mattino del 5 agosto 1937 mi ero presentato al Comando del 4° artiglieria alpina, a Cuneo, per iniziare il servizio militare in qualità di aspirante sottotenente veterinario di complemento. Il grande casermone del reggimento, la «Cesare Battisti», che faceva corpo unico anche per i reparti del 20° reggimento alpini, era deserto. Tutti gli alpini e gli artiglieri alpini erano fuori sede, con le salmerie al seguito, impegnati nel ciclo delle esercitazioni estive nella zona Lago delle Mescie Valle Casterino, la Valle delle Meraviglie.
Ero entrato nella «Battisti» con addosso tutti i paramenti dell’alta uniforme per la presentazione al comandante di reggimento. Mi aveva ricevuto il tenente Bordini, aiutante maggiore in I^ del reggimento stesso. Dopo i convenevoli di rito Bordini aveva tagliato corto dicendomi: «Togliti tutto il “someggio” da giuramento. Il signor Colonnello comandante non c’è, è su per un ‘ispezione ai reparti in esercitazione. Ergo: mettiti in divisa da fatica, infilati gli scarponi, prenditi il sacco da montagna con entro i tuoi effetti personali, sali sul primo treno in partenza da Cuneo per Nizza, scendi a Tenda, ti fai a piedi un tre ore di salita, raggiungi il Lago delle Mescie e qui ti presenti al Comando del Gruppo Pinerolo al quale sei stato assegnato. Lassù farai il giuramento non con la sciabola ma con la pistola. Ciao e in gamba ».
Mi sentivo talmente in gamba che salito sul primo treno utile del pomeriggio e sceso a Tenda, alle 18, in meno di due ore compivo la tappa. Una gran volata sorretta dalle ali dell’entusiasmo per la mia prima penna nera.
Nella tenda comando del Pinerolo trovai un solo ufficiale e mi presentai. Era il mio diretto superiore tecnico, cioè il capo servizio veterinario del reggimento, il capitano Alfredo Manzone, un imponente ercole di mezza età che portava sul petto una successione di nastrini di tutto rispetto: prima guerra mondiale, operazione riconquista Cirenaica, guerra di Spagna, campagna d’Abissinia, croce al merito coloniale, croce da cavaliere e tante altre cose ancora. Aveva un vocione da orco, ma da orco benefico. Mi accolse a braccia aperte, come un vecchio amico, mi fece accomodare: «Immagino che questo signorino abbia fame» disse e subito straziò la pace dei monti con un urlo: «Giovenaleee!».
|
Giovenale arrivò di corsa, era il mensiere. «Subito da mangiare per il signorino». E il signorino si fece una gran mangiata.
Soddisfatto per la paterna accoglienza chiesi al mio simpatico capo servizio quali erano gli ordini per il giorno dopo. Manzone si incupì di colpo, mi guardò con tenerezza e cosi mi disse: «Caro figliolo, avete da svolgere subito un servizio non precisamente allegro. Mezz’ora prima deI vostro arrivo un portaordini del capitano Pausini, comandante di una batteria, lo conoscerete presto, un gran soldato, mi ha avvisato che a due ore di marcia e precisamente in questo punto» mi aveva accompagnato intanto presso una carta topografica del settore, che stava affissa contro un telo della tenda «e sulla mulattiera c’è un mulo gravemente infortunato: probabile frattura di uno stinco. Il capitano Pausini ha chiesto l’intervento di un ufficiale veterinario. Se sussiste realmente la frattura il quadrupede deve essere abbattuto. Pausini è in spostamento notturno. Molto probabilmente la bestia è stata lasciata sola. Mi spiace, tocca a voi andare su. Con tutto quel che potrà seguire. Tutto ciò non ho voluto dirvelo prima per non rovinarvi la cena. Mi spiace, giovane collega. Il mulo si chiama Orvieto».
Prima incombenza di servizio, bell’incombenza: accoppare un innocente. E non per colpa del 1° capitano Manzone o del 1° capitano Pausini, ma per via, questa volta, di un eccesso di genialità creativa, si fa per dire, del Padreterno che, evidentemente mortificato per gli sbagli compiuti nella messa in opera dell’apparato gastroenterico degli equini - di cui ho già parlato - aveva forse ritenuto opportuno riparare al malfatto gratificando i predetti animali di un’opera fisioanatomica tra le più perfette del creato: i metacarpi, vulgo gli stinchi, ossa gracili se rapportate a quelle dell’uomo, ma costruite con un’architettura incomparabile tutta spinte, controspinte, sovrapposizioni di archi a tutto sesto, a sesto acuto, rampanti, rialzati, a ferro di cavallo; e poi controarchi, lunette, angoli a peduccio, contrafforti. Quei quattro stinchetti, i «fiammiferi» come li chiamano gli allevatori francesi, sono in grado di sopportare, ad esempio, il sovrappeso di quattro, cinque quintali che cadono dall’alto (il peso di un cavallo da concorso ippico che atterra sui due anteriori dopo avere superato l’ostacolo) e non fanno «beh» sotto i carichi enormi e pressanti di muli someggiati giù per discese ripide. Un capolavoro irripetibile, che già aveva lasciato di stucco Leonardo da Vinci e che, purtroppo, non è suscettibile di «riparazioni» allorché si spezza. Se anche l’arto dell’animale potesse essere ingessato il callo osseo neoformato non potrebbe evitare la permanente zoppia del soggetto al quale occorrerebbe, per il ritorno alla normalità, un ripristino praticamente impossibile della mirabile armonia architettonica che ho descritto.
E così mi misi in cammino verso il mulo Orvieto. Prima di partire avevo vuotato il sacco delle cose mie e le avevo sostituite con una lampadina elettrica, una borraccia piena d’acqua, due panini e una giubba a vento contro il freddo della notte; avevo incluso nel sacco anche una borsetta di medicazione. Chissà, forse non era una frattura.
Salii spedito la mulattiera, favorito nella marcia dal chiarore di una grande fetta di luna. Dopo un’ora di cammino mi giunse all’orecchio un tintinnio di ferri. Erano i ferri degli zoccoli del mulo. Orvieto aveva a sua volta udito il rumore dei miei passi e mi stava venendo incontro. Dopo pochi minuti lo vidi: veniva giù a lenti balzelloni, a capo chino, con l’anteriore sinistro trattenuto a mezz’aria. Mi si avvicinò quieto. Sentii la mia voce che gli diceva «Ciao, Orvieto, come va?». Gli accarezzai il bel testone e poi feci scendere una mano lungo la spalla sinistra e poi lungo l’arto sino ad arrivare allo stinco. La diagnosi, alla semplice ispezione manuale, fu sin troppo facile: frattura netta. Dovevo abbattere il quadrupede.
Afferrai il mulo per la cavezza e lo trascinai lentamente, in discesa, verso uno spiazzo che a poche decine di metri dal punto del nostro incontro allargava la mulattiera. Orvieto mi seguì docile, un passo con l’anteriore sano, un faticoso salto con i due posteriori. Non gemeva ma respirava affannato; giungeva forte alla mano che teneva la cavezza e al mio viso che sfiorava il muso del mulo, il calore del suo stato febbrile. Ci fermammo sullo spiazzo e Orvieto tirò un gran sospiro. Accesi la lampadina e illuminai l’animale. Aveva tirato su la testa e vidi i suoi grandi occhi lucidi che guardavano fiduciosi ad un improvvisato e forzato boia che mai, mai prima di allora aveva recato offesa manuale ad un rappresentante degli ibridi.
Mi sfilai il sacco, ne trassi fuori tutto il contenuto e lo posai su un sasso. Cavai dalla fondina la Beretta cal. 9, inserii il caricatore e collocai la pistola su un altro sasso. Avevo la gola arsa, ma non per la fatica della salita, e così tolsi il tappo dalla borraccia e buttai giù una sorsata d’acqua. Orvieto abbozzò un mezzo raglio lamentoso: aveva sete. Anche Gesù ebbe sete prima di morire. E questo fu un pensiero tristissimo. Mi tolsi il cappello alpino, lo riempii dell’acqua della borraccia e lo porsi al mulo. In tre secondi il recipiente fatto di panno fu prosciugato.
Fu a questo punto che mi venne l’idea di dare uno sguardo al contenuto della borsa di medicazione. Tra aghi e seta per sutura, lacci di contenimento, un piccolo matereccio di tintura di iodio, una fascia e due piccoli pacchi di cotone idrofilo, trovai anche una agocannula, un aggeggio per praticare salassi. Un salasso, ecco Orvieto, un salasso. Sarà una fine dolce, indolore; sarà come essere posseduto da un gran sonno. E così evitiamo la pistola. Nell’ultimo istante della tua vita non sentirai il colpo destinato a spaccarti il cervello e non vedrai la fiammata della morte.
Presi un laccio e lo strinsi attorno al collo del mulo; subito le giugulari apparvero tonde, turgide. Orvieto lasciava fare, sempre quieto. Presi anche un panino, tolsi l’orribile rnortadella che lo imbottiva, e lo offrii al mulo. L’animale masticò placido e quasi non si accorse della rapida introduzione dell’agocannula in una delle sue grandi vene giugulari. Dalla cannula trassi via il grosso ago e il sangue incominciò a zampillare copioso. Spezzai in più parti il secondo panino e ogni tanto offrivo a Orvieto un pezzetto di pane. Ad ogni movimento masticatorio corrispondeva una più vorticosa uscita di sangue dalla cannula.
Passarono molti minuti. Orvieto masticava ora le manciate d’erba che avevo raccolto nei pressi dello spiazzo. Ad un tratto drizzò le orecchie, come sorpreso, poi traballò un poco, si piegò sugli arti posteriori e lentamente si distese a terra, su un fianco. Il respiro si fece calmo, sottile, sempre più sottile. Accesi ancora la lampadina ed esplorai gli occhi dell’animale: incominciavano a velarsi ma non intravidi in essi terrore o sofferenza. Ero seduto anch’io a terra, all’altezza del petto di Orvieto, e stavo accarezzandogli il muso, allorché il suo cuore cessò di battere.
Disse una volta il prof. Herlitzka, docente di fisiologia, a noi studenti dell’Università di Torino: «Abbiate sempre motivo di rispetto e di tristezza per la morte di ogni animale, minuscolo o grosso che sia, perché nel momento in cui quell’essere muore viene distrutta un’armonia di cellule e di messaggi creata da milioni di anni di evoluzione. Soprattutto di messaggi. Grande uomo, quell’Herlitzka.
L’episodio di Orvieto accadde, come ho detto, circa tre anni prima dell’inizio del secondo conflitto mondiale e non immaginavo allora, quali e quanti sarebbero stati le sofferenze e i «tipi» di morte, soprattutto sul fronte greco albanese, di tanti nostri muli. Quei grandi innocenti dalle orecchie lunghe...
Giuseppe Bruno
|
 |
"La salita del Monte Ventoso"
Tra le pagine letterarie minori del grande poeta e scrittore Francesco Petrarca ve n'è una che, unica nel suo genere, contiene la descrizione della salita al monte Ventoso fatta oltre 650 anni fa dallo stesso grande poeta.
L'autore del Canzoniere in una lettera ad un padre agostiniano, descrisse in modo particolareggiato l'ascensione effettuata con il fratello Gherardo il 26 aprile 1336 al relativamente modesto monte Ventoso, molto noto agli sportivi del ciclismo ( Mont Ventoux). E' questa una montagna alta 1912 metri nel dipartimento Valchiusa a nord-est di Avignone, dove il padre del giovane poeta, deceduto alcuni anni prima, era impiegato al seguito della Corte papale. Il testo, scritto in lingua latina, è stato tradotto nel secolo scorso anche da un altro grande poeta e primo premio Nobel italiano per la letteratura, Giosuè Carducci che fu grande studioso e ammiratore del Petrarca. La descrizione, come detto, è particolareggiata e contiene numerosi riferimenti storici, letterari e religiosi.
Programmata l'escursione per il 26 aprile, in modo di avere molte ore di luce e il clima favorevole, i fratelli raggiunsero Malaucena che è alla base del monte, con due giorni di anticipo.
"Non ci mancava né la buona volontà né la vigoria fisica, ma", annota il poeta, "quella gran mole di roccia era davvero scoscesa e quasi inaccessibile". In un anfratto del monte incontrarono un vecchio pastore che cercò di dissuaderli dall'impresa dicendo loro che cinquant'anni prima: "provai la giovanil fantasia di salire ma non ne riportai che pentimento e stanchezza".
Poiché non convinse i due fratelli a desistere, il vecchio indicò loro la via da seguire, non solo, si prestò anche a custodire gli indumenti e i materiali che ingombravano inutilmente i due giovani alpinisti ed il loro seguito.
Dopo un primo tratto percorso con Iena e agilità, si dovettero fermare a riposare sul ciglio di una rupe.
Il fratello, poi, salì lungo la linea di massima pendenza seguendo una ripida scorciatoia, il poeta invece si aggirò cercando una strada più lunga e meno faticosa, ma inutilmente, anzi, essendo questo un pretesto per la pigrizia, come egli stesso confessa, il girovagare lo portò per ben tre volte molto più in basso rispetto al fratello, allungando così il percorso e la fatica. Finalmente dopo questi insuccessi, si decise a salire lungo l'erta e, ansante, raggiunse il fratello, che nel frattempo, si era riposato a lungo.
Quando giunse sul pianoro della cima più alta del monte denominata Figliolo, il poeta si commosse e stette come trasognato per "lo spirar leggero dell'aere e del vasto e libero spettacolo". Come si vede, gli ampi orizzonti che si godono sulle cime faticosamente conquistate, sono sempre commoventi per gli uomini, allora come oggi. Il monte Ventoso è una montagna che si erge relativamente isolata e consente quindi una visione ampia e spettacolare.
Sulla vetta il Petrarca si commosse anche guardando verso le Alpi marittime e l'Italia e ammette: "Sospirai, lo confesso, verso il cielo d'Italia che all'animo, più che agli occhi appariva, e un'ineffabile ardore mi pervase di rivedere la Patria".
A questo punto della lettera, il poeta ricorda, sempre guardando le Alpi, che Annibale, quando le attraversò nell'anno 218, allo scopo di creare dei gradini o dei piccoli varchi sulle rocce, le faceva surriscaldare col fuoco e poi vi faceva versare l'aceto, come narra Tito Livio nel libro XXI della sua opera ab Urbe condita (ardentia saxa infuso aceto putrefaciunt).
|
Come spesso accade agli alpinisti, che approfittano del raccoglimento che la montagna favorisce per fare un bilancio di un periodo della propria vita o della vita stessa, anche Petrarca in quella occasione fece un bilancio dei dieci anni trascorsi in Francia dopo aver lasciato gli studi giovanili e Bologna E il suo pensiero si rivolse a Dio con una fervida preghiera usando le parole di Sant'Agostino del quale aveva con sé il libro "Le Confessioni". A questo proposito dirò ancora che aprì il volume casualmente e gli occhi caddero sul passo che diceva e gli uomini vanno ad ammirare le altezze dei monti, gli enormi flutti del mare e abbandonano sé stessi".
È particolarmente significativa la corrispondenza casuale tra il bearsi del poeta nella grandiosità del panorama alpino e la citazione dello stesso concetto fatta quasi mille anni prima da parte del grande scrittore, teologo e filosofo sant'Agostino che lo ricordava come un'abitudine edonistica dei suoi tempi. La frase di S. Agostino fece pentire il Poeta di aver ammirato troppo le cose terrene "quando da un pezzo avrei dovuto imparare anche dai filosofi pagani che niente è degno di ammirazione fuorché l'anima".
Durante la discesa continuò nelle considerazioni morali e religiose, sui destini dell'anima e in alcune riflessioni ascetiche che gli fornirono l'occasione di citare un famoso passo di Virgilio, senza peraltro nominarlo "Felix qui potuit rerum cognoscere causas" (felice chi poté conoscere il perché delle cose).
La sera stessa il Petrarca scrisse la lettera al frate Dionisio di S. Sepolcro.
La salita al monte Ventoso è la prima, sia pure modesta, prova di alpinismo turistico-escursionistico di cui si abbia notizia.
Lo stesso Petrarca narra dell'ascensione fatta dal re di Macedonia Filippo V sul monte Emo in Tessaglia, unitamente ad alcuni generali, allo scopo di poter vedere i due mari: il Mar Nero (Eussino) e l'Adriatico. L'ascensione, confermata da Pomponio Mela e messa in dubbio da Tito Livio, non può in ogni caso essere catalogata come escursione turistica, specialmente se si tiene conto delle mire espansionistiche del monarca.
Numerosi autori affermano che non si conosce nessun'altro che prima del Petrarca, il grande precursore dell'umanesimo, sia salito su un alto monte solo per il "multa videndi ardor ac studium" ( per la brama e il gusto di vedere molte cose) come si esprimerà lo stesso poeta parlando dei suoi viaggi sui Pirenei, in Francia e in Germania. Non solo, ma è il primo brano letterario che tratti compiutamente e analiticamente un argomento strettamente connesso con la montagna.
"Multa videndi ardor ac studìum" ! Sono parole magiche che fanno muovere milioni di persone, vuoi per esplorare le foreste e le montagne e vuoi per ammirare le opere d'arte realizzate nei secoli dall'uomo; comunque per conoscere.
Un brano letterario di argomento alpinistico di un così grande poeta, scritto agli albori della lingua e della letteratura italiana , assume per gli alpinisti e per la letteratura di montagna un significato di grande rilievo. Ciò anche perché è imbevuto di nobili ed elevati sentimenti che scaturiscono in modo naturale e senza forzatura dal contesto del racconto.
Vittorio Pacati
Da una relazione dell'autore effettuata il 26-2-00 in occasione della cerimonia di premiazione del premio letterario "Putia" - terza edizione - istituito dalla Sezione di Bressanone del Club Alpino Italiano. Il saggio è stato pubblicato dalla rivista " UNUCI" n° 7/8 del 2001.
|
 |
"L'ultimo contrappello"
Dodici Maggio, molti anni fa.
Un treno fischia, sbuffa e lentamente
si muove, il Corso «FEDE» se ne va
con il filetto da Sottotenente
Tutti presenti, tutti di una sorte:
stringendo il suo destino fra le dita,
così ciascuno andò verso la vita,
così qualcuno andò verso la morte.
E quando la bufera fu passata,
quando quel treno si rimise in moto
per condurci alla prima radunata,
aveva a bordo più di un posto vuoto.
Amici della prima giovinezza,
rimasti nella steppa ed oltremare,
noi che ci ritrovammo a ricordare
noi vi pensammo: ma senza tristezza.
Voi caduti nel fango e sulla cima
dei monti, missionari del coraggio,
foste compagni del consueto viaggio
scesi dal treno una fermata prima.
Anche quest'anno il treno si è fermato
per radunarci e per condurci ancora
a ritrovare insieme per un'ora
le rugose radici del passato.
|
Eccoci ancora qui, tutti presenti
ed ancora una volta tutti uguali:
avvocati, ingegneri, generali,
ma tutti ancora un po' sottotenenti.
Certo è che il treno un dì s'arresterà
(e a bordo avrà soltanto un passeggero)
s'arresterà in un sibilo leggero
al Gran Quartiere dell'Eternità.
Saremo pronti all'ultimo raduno,
del Corso «FEDE». Amici, sarà bello
fare ancora una volta il contrappello.
Quel giorno, si, non mancherà nessuno.
E passeremo in riga nuovamente,
e fra tutte le stelle di lassù
una soltanto brillerà di più:
una stella da sottotenente.
Padre Gianfranco Chiti
Questa poesia, esposta nel convento dei Cappuccini di Orvieto, è di Padre CHITI, notissimo ed eroico Ufficiale dei Granatieri che, finito il servizio attivo con il grado di Generale, ha sentito la vocazione di porsi al servizio dell'ordine monastico come umile frate. Anche in questo ruolo Padre CHITI ha continuato a profondere le sue migliori energie a favore di coloro che si sono rivolti a Lui con FEDE, fino a pochi giorni fa. Ora anche Lui è sceso dal treno "a una fermata prima". In suo ricordo pubblichiamo questa sua toccante poesia.
(DA TRADIZIONE MILITARE DEL 2 FEBBRAIO 2005) Si ricorda che una delle prime missioni svolte da Padre Chiti, non appena ordinato sacerdote, è stata quella di celebrare il Precetto Pasquale a favore dei militari della Brigata Alpina Tridentina nell'Abazia di Novacella negli anni '70. [nota del redattore]
|
 |
"Cappellani in tempo di guerra"
Mi trovavo con colleghi parroci alla caserma del 121° qui a Bologna ed il discorso cadde sul cappellano militare in tempo di guerra. Un collega rivolgendosi al Vescovo Mons. Marra, voleva ironizzare: “... come può il buon Dio ascoltare insieme il cappellano che prega per i suoi di qua dalla trincea e il cappellano che prega per i suoi dall’altra parte della trincea...”
Mons. Marra, lentamente, scotendo il capo “... e voi; quei ragazzi, vorreste lasciarli soli?!..”
Chi è il Cappellano militare?
È un prete come tutti i preti, crede in Dio e nella gente; e per amore di Dio, si fa carico delle gioie, dolori, fatiche e speranze di quanti gli vengono affidati, per camminare con loro alla luce della fede. Per cui se gli vengono affidati giovani e questi un bel giorno debbono partire per il fronte, egli chiede ed essi chiedono di andare con loro: è la vicenda, tra le tante, di
Don Primo Mazzolari e di Don Carlo Gnocchi.
Cappellano militare può essere un tranquillo Padre Francescano che vive nel suo Convento e un giorno gli viene detto che dovrà deporre il saio per indossare la divisa grigioverde e andare in un Ospedale da campo. Ed egli parte e non è che provi chissà quale trauma: prima serviva Cristo educando i novizi in convento, ora serve Cristo ferito, sanguinante su una brandina!
Quando il cappellano reduce da una guerra viene chiamato nelle scuole e i ragazzi gli obiettano “Come mai, tu che sei prete, sei andato a fare la guerra?” Il Cappellano risponde: “non sono andato a fare la guerra ma c’erano giovani che andavano a fare la guerra e mi hanno detto:
“vieni con noi; tu non vieni per sparare; tu ci aiuterai a pregare e se saremo feriti, ci starai vicino; se saremo uccisi, a casa nostra non andrà solo il maresciallo dei carabinieri a dare la notizia, ma arriverà anche la tua lettera per dire che abbiamo fatto il nostro dovere
fino in fondo e che siamo morti da cristiani...
Il Cappellano dunque non spara? Può capitare che il plotone veda cadere il tenente; c’è lo sbandamento; il cappellano è lì; bisogna salvarli quei fanti; e l’unico modo è di prendere l’arma in mano e di mettersi alla testa del plotone: e così fece
Don Silvio Marchetti il 20 dicembre 1942 a Kantemirowka. Fu sopraffatto, fu ucciso; ma non importa; in quel momento egli doveva fare così.
E poi c’è la legittima difesa; Don Carlo Chiavazza nel suo libro “Scritto sulla neve” dice che un russo gli si è avventato addosso ed egli l’ha prevenuto e l’ha ucciso.
E’ il caso di Don Michele D’Auria: nell’isba in cui si trova entrano due soldati russi che gli sparano; si getta sotto il tavolo; si finge morto; ha modo di estrarre la pistola e fa fuori i due russi. Legittima difesa; legittima per tutti, anche per il cappellano.
Ma l’arma vera, l’arma in dotazione, obbligatoria per il cappellano in guerra, non è tanto la croce rossa cucita sul taschino della giubba, ma il Crocefisso, un Crocefisso vero, e l’altarino con il Calice. Ed ora si impone una digressione. Il Cappellano sa che Cristo, il suo Maestro, redime il mondo versando il Suo Sangue. E conosce il commento dell’Apostolo Paolo, quando dice che la Passione di Cristo non è completa senza la sua passione; l’Apostolo si dice lieto per essere chiamato a completare con la sua, quello che manca alla Passione di Cristo. Cristo è solo il capo; le membra siamo noi; il capo dona il Suo Sangue, le membra facciano altrettanto.
Soprattutto i preti. Santa Caterina da Siena chiamava i preti “ministri del sangue” definizione che il Card. Giulio Bevilacqua applicava in particolare ai cappellani militari; diceva; “Noi siamo i ministri del sangue; con quello di Cristo, il sangue di chi ci cade accanto, il nostro stesso sangue; nell’unico calice, per la redenzione del mondo”.
Il 26 dicembre 1941 cade nella battaglia di Petropawlowska Don Giovanni Mazzoni del
3° Bers.; il 26 agosto ‘42 cadono in combattimento Don Ferrucci Moranti del 47° Btg. Bers. Motociclisti e
Don Francesco Mazzocchi del 1° Btg. Chimico; il 16 dicembre ‘42, sempre in combattimento, cade
Don Felice Stroppiana dell’81° ftr. della
Torino.
Alla mattina questi cari colleghi (ho avuto la fortuna di conoscerli), avevano detto la loro Messa. Statene certi che anche quella mattina, la preghierina solita l’avevano detta: “Signore, se oggi col tuo sangue ci vuoi mettere anche il mio, sappi che non mi dispiacerebbe; insieme a quello dei miei ragazzi”.
E il Signore in quel giorno accolse la loro offerta.
Ma attenzione! Non è che questi cappellani si siano gettati nella mischia per cercare una bella morte sia pure nel nome di Cristo: avevano qualcuno da salvare! A questo punto, una parentesi.
Quando fra le due guerre, negli anni venti, il governo italiano discusse l’opportunità o meno della presenza permanente del cappellano nell’esercito, qualcuno obiettò che in guerra il cappellano non contribuisce a rafforzare i nervi del soldato per l’assalto; il cappellano, al soldato, ricorda troppo la mamma lontana; non aiuta il soldato a stringere i denti... Il 16 dicembre 1942, trovandosi chi vi parla al caposaldo “Venere” sul Don, avendo incontrato in un angolo buio dei camminamenti due fanti... “cosa fate qui?!” “Cappellano, abbiamo paura!” “ma i vostri compagni sono fuori a combattere! Se vi trova qui il capitano vi spara!”
Il cappellano ha fatto uscire i due fanti; forse li ha mandati a morire; ma il suo dovere in quel momento era quello, anche se tutte le volte che rievoca il fatto, il suo cuore sanguina!
|
Abbiamo accennato al Cappellano che, più di ogni altro ufficiale, ricorda al soldato la famiglia; quando si scrive dal fronte, in fondo alla lettera spesso e volentieri viene sollecitata l’aggiunta del cappellano... “... lo dica Lei a mia madre che sto bene; a me non crede... le dica che non mi manca niente... “. Si stabilisce così un vero legame fra il cappellano e la famiglia; il cappellano diventa un po’ mamma, papà. Ed allora potrebbero aver ragione quelli che pensano non opportuna la presenza del cappellano in linea. Torniamo per un momento al caposaldo “Venere”. Ci chiediamo: se al posto del cappellano ci fosse stato sua madre, li avrebbe mandati a combattere? Terribile, una madre vera li avrebbe fatti uscire: per fare il loro dovere! Così come una madre si sarebbe lanciata per soccorrere suo figlio ferito a Petropawlowska, a Serafimovic, a Monastircina; al posto della mamma,
Don Mazzoni, Don Ferrucci Moranti, Don Felice Stroppiana dicevamo più sopra:... avevano qualcuno da salvare...
Sentirsi “famiglia” per ragazzi di vent’anni mandati a combattere verso il circolo polare artico: ecco il cappellano in Russia. Ascoltate la pagina di
Don Carlo Gnocchi da “Cristo con gli Alpini”: “... Era un ferito grave e già presso a morire. Quando gli tolsero adagio, devotamente, la giubba, apparve la veste atroce e gioconda del sangue, che, come un velo liquido e vivo, fasciava e rendeva brillanti le membra vigorose. Senza parlare mi guardò. I suoi occhi erano colmi di dolore e di pietà, di volontà decisa e di dolcezza infantile. Al fondo vi tremava, attenuandosi, la luce di visioni beate e lontane. Come di bimbo che si addormenta poco a
poco...”
Don Gnocchi rivela in queste righe la sofferenza del cappellano, che si fa ben più viva quando gli tocca comporre il plico con le foto, le lettere, gli oggetti portati da casa che non servono più, perché il soldato è lì, morto davanti a lui. Bisogna spedire il plico a casa con una tua lettera, cappellano.
Il maresciallo dei carabinieri porterà l’annuncio ufficiale del decesso; ma la famiglia aspetta la tua lettera; vuole sapere come è morto, le sue ultime parole che solo tu hai sentito. Vuol sapere come l’hai sepolto e se è possibile, vorrebbe la foto della croce sulla sua tomba, con il suo nome. Solo Dio sa quello che provi, cappellano, quando ti tocca aprire la terra col piccone perché
è dura come il marmo per il gelo e mettere la bottiglietta sigillata con il nome del caduto dentro la cassa o nel telo. Ti può capitare di leggere quel biglietto con la tua firma dopo 55 anni, perché il bersagliere l’hanno trovato e l’hanno portato a casa.
L’amore del cappellano ai suoi soldati lo fa diventare stratega. Nel gennaio ‘42 entrò malato nel mio Ospedale da campo
Don Guglielmo Biasutti cappellano della Legione Tagliamento. Di lui mi avevano già parlato i suoi militi; gli volevano bene più che a un padre. Uno mi disse: “Io ho a casa due bambini. Se il Signore mi chiedesse uno dei miei bambini o il cappellano, non saprei chi dargli”. Arriva a far visita al Cappellano il Comandante della legione.
Don Biasutti lo mette in imbarazzo perché esclama: “Comandante, non mandi i militi a morire a Voroscilova; non serve a niente occupare Voroscilova!”. In seguito fu riconosciuto dai comandi che aveva ragione il cappellano.
Il quale un bel giorno non ce lo trovammo più in corsia; era tornato in linea. Se c’era un ufficiale che contribuiva a rinsaldare i nervi dei suoi nell’affrontare ogni evenienza, era proprio lui; tornava in linea ad incitare ed a difendere.
Emilio Lussu nel suo celebre “Guerra sull’altipiano” dice di un cappellano austriaco che riuscì a far cessare una inutile avanzata. I nostri dovevano a tutti i costi occupare una posizione; cadaveri si ammucchiavano a cadaveri; il suo intervento avrebbe fatto cessare l’inutile strage.
Una domanda provocatoria: “Cappellano, ma tu, alla Patria vuoi bene sì o no?! Hai parlato di famiglia, di fede, ma la tua Patria dov’è?!” Al cappellano non è difficile rispondere: “Se esorto i soldati a compiere il loro dovere fino alla morte, lo faccio perché credo alla Patria che dobbiamo amare fino a dare la vita per lei”. Quando celebra la Messa, più volte la liturgia gli fa baciare l’altare, ma il suo altare è il Tricolore; il suo calice è sempre poggiato al centro del Tricolore, che egli porta in dotazione nel suo altarino da campo.
Nel campo di prigionia in Russia, campo 74, scoppia il tifo petecchiale. Vengo chiamato da un alpino che sta morendo. “Cappellano, vedi come mi tocca di morire! Guarda che squallore! Venendo in guerra, sapevo che potevo morire ma non in un lazzaretto di appestati; morire combattendo! Gridando! Gridando Viva l’Italia!”. Dovrei piangere ma non ne ho la forza;
guardo, guardo con tutta la tenerezza quella vita, luce che si spegne. Ma l’alpino riprende a parlare:
“Cappellano, è la stessa cosa: anche qui muoio per l’Italia”.
La morte gli dischiude la mano; nella mano, un piccolo tricolore. Quel giovane alpino aveva attinto dalla sua bandiera stretta forte durante l’agonia, la forza di morire con la dignità di un eroe. Ho conservato quella bandiera dall’aprile ‘43 fino a settembre ‘46 quando a Fossano la potei consegnare a sua madre. Sono riuscito a sottrarla a tutte le perquisizioni e vi confesso che anche a me quel lembo
d’Italia ha dato la forza per superare ogni prova e comportarmi da italiano verace!
Mons. Enelio Franzoni
Bologna, 12 aprile 1996
Conferenza tenuta al Circolo Ufficiali dell’Esercito a BOLOGNA il 12 aprile 1996
da Mons. Enelio Franzoni, Medaglia d’Oro al Valor Militare (per gentile
concessione del Cap. Freg. (A.N.) Ing. Giuliano Giacopini, Presidente del Centro Studi Storico
Militari di Bologna).
|
 |
"Preghiera dell'Alpino"
Sulle nude rocce, sui perenni ghiacciai, su ogni balza delle Alpi
dove la Provvidenza ci ha posto a baluardo fedele delle nostre contrade,
noi, purificati dal dovere pericolosamente compiuto,
eleviamo l'anima a te, o Signore
che proteggi le nostre mamme, le nostre spose, i nostri figli e fratelli lontani
e ci aiuti ad essere degni delle glorie dei nostri avi.
Dio onnipotente, che governi tutti gli elementi,
salva noi, armati come siamo di fede e di amore.
Salvaci dal gelo implacabile, dai vortici della tormenta,dall'impeto della valanga; fa che il nostro piede posi sicuro
|
sulle creste vertiginose, sulle diritte pareti, oltre i crepacci insidiosi;
rendi forti le nostre armi contro chiunque minacci la nostra Patria ,la nostra Bandiera, la nostra millenaria civiltà cristiana.
E tu Madre di Dio, candida più della neve,
Tu che hai conosciuto e raccolto ogni sofferenza ed ogni sacrificio di tutti gli Alpini caduti,
Tu che conosci e raccogli ogni anelito ed ogni speranza di tutti gli Alpini vivi ed in armi,
Tu benedici e proteggi i nostri Battaglioni e i nostri Gruppi. Così sia.
(stesura tradizionale)
|
 |
"Preghiera dell'Alpinista"
Dio onnipotente che hai voluto infondere
nell'universo creato
il segno della Tua potenza e della Tua
magnificenza, aiuta noi che, conquistati dal fascino
e dalla maestosità delle nostre montagne,
ne percorriamo i sentieri, ne scaliamo le vette,
ne contempliamo e proteggiamo i silenzi
e le incontaminate multiformi bellezze.
Proteggi e ricompensa i componenti
delle unità di soccorso alpino
e fa che il loro impegno e il loro sacrificio
raggiungano sempre la meta prefissa.
Guida e aiuta nella loro opera
gli accompagnatori di alpinismo giovanile,
perché conducano sempre con mano ferma
i nostri ragazzi sui sentieri della montagna
e sui sentieri più ardui ed impegnativi
|
della conoscenza e della rettitudine.
Proteggi le guide, i maestri, gli istruttori,
gli alpinisti, gli speleologi, gli sciatori
e tutti coloro che in montagna vivono ed operano
o cercano sollievo dalle sofferenze fisiche e morali,
salvali dai pericoli e dalle insidie
e fa che la montagna sia palestra
di accrescimento spirituale.
Accogli sulle più elevate cime
del Regno Celeste i Caduti della montagna
e tutti i nostri fratelli che ci hanno preceduto
nella fede e nella passione per l'alpinismo.
Concedi infine che la bellezza della natura
e la grandiosità del creato contribuiscano
ad aumentare in chi le ammira
la fede in Te e nella Tua immensa bontà.
|
 |
"Preghiera alla Madonna della neve"
O Maria,
donna delle altezze più sublimi,
insegnaci a scalare la santa montagna
che è Cristo.
Guidaci sulla strada di Dio
segnata dalle orme dei Tuoi passi materni.
Insegnaci la strada dell'amore,
per essere capaci di amare sempre.
Insegnaci la strada della gioia,
per poter rendere felici gli altri.
Insegnaci la strada della pazienza,
per poter accogliere tutti con generosità.
Insegnaci la strada della bontà,
per servire i fratelli che sono nel bisogno.
Insegnaci la strada della semplicità,
per godere delle bellezze del creato.
Insegnaci la strada della mitezza,
per portare nel mondo la pace.
Insegnaci la strada della fedeltà,
per non stancarci mai nel fare il bene.
Insegnaci a guardare in alto,
per non perdere di vista
il traguardo finale della nostra vita:
la comunione eterna
con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
|
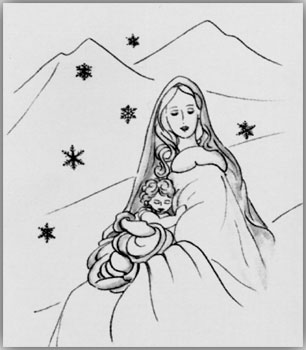
|
I rifugi storici del CAI (1)
IL RIFUGIO "GENOVA" al Passo Poma
costruito dagli Alpinisti di Dresda.
Il rifugio Genova è ubicato in una splendida posizione nel Parco Naturale Puez-Odle, nell’alta Val di Funes in provincia di Bolzano, con un panorama spettacolare sulle Dolomiti.
Nei pascoli intorno crescono la genziana maggiore, la nigritella e, poco più in alto, le stelle alpine. La particolarità della posizione ha sicuramente colpito l’alpinista di Dresda, Franz Schlüter, che qui decise di realizzare una costruzione, il Rifugio Genova appunto, che poi donò alla sezione alpinistica della sua grande città sul fiume Elba.
 Franz Schlüter.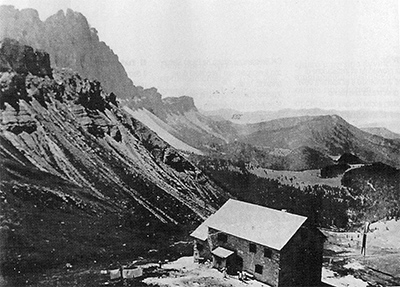 Schlüterhütte fino al 1907.
La Val di Funes (in tedesco Villnöss) e le Dolomiti.
La Val di Funes, laterale della Val d’Isarco, è una valle molto bella, anche se meno famosa della vicina Val Gardena. Proprio per questo motivo la natura è rispettata in modo particolare.
S. Pietro dove c’è la sede comunale, S. Maddalena e Tiso sono i più importanti centri abitati. Molti toponimi ricordano l’antica popolazione dei Reti.
Stazione climatica e turistica conosciuta e frequentata, vi è molto sviluppato il turismo invernale e, in misura maggiore, quello estivo. Si possono fare splendide passeggiate, escursioni e ascensioni di qualsiasi difficoltà. Vi sono anche opere d’arte di matrice religiosa; molto bella la chiesetta di S. Giovanni in Ranui, che, con lo sfondo delle Odle è usata spesso come simbolo della Valle. Una curiosità assolutamente particolare è un‘antica fossa per catturare i lupi, risalente al 1518.
Nei boschi di Tiso, che è sulla dorsale allo sbocco della valle, sono reperibili, (ma sono protetti) i geodi conosciuti come noci di Tiso. Queste bellissime sfere di roccia parzialmente cave contenenti ricchi e variegati cristalli di quarzo o ametiste (druse) possono essere ammirate nel locale museo. Al di fuori dei centri abitati si respira ancora l’aria del XIX secolo.
I masi (le fattorie) sono abitati e coltivati ancora sovente con metodi primitivi che suggeriscono ataviche scene agresti e bucoliche. I fianchi della montagna presentano pendii gradevoli coperti da prati, ma soprattutto da riposanti boschi di conifere.
A Malga Zannes è possibile vedere caprioli e daini convalescenti che pascolano tranquillamente in un ampio recinto gestito dalla Forestale. In montagna è ancora possibile incontrare caprioli, stambecchi e camosci nel loro ambiente naturale. L’appassionato fotografo può catturare immagini di scoiattoli e di ogni tipo di uccello, I ruscelli scorrono in tortuosi letti di roccia e ghiaia di colore bianco-perlaceo che rievocano ”i rivi d’argento” dell’inno del Club Alpino Italiano.
E’ proprio in questo contesto ancora rispettato che sorge il Rifugio Genova, in mezzo ad un prato verde intenso in prossimità del Passo Poma, con vista incantevole sul versante alpinisticamente più bello delle Odil. Queste (letteralmente aghi in ladino) si ergono, ardite e strapiombanti, dai ripidi ghiaioni bianchi sulla sinistra idrografica della valle. Sulla destra le più modeste Odle di Eores mostrano il versante più dolce.
In questa valle è nato e cresciuto anche alpinisticamente il famoso Reinhold Messner, Socio Onorario del Club Alpino Italiano. Sulle Odle di Eores, poco distante dal rifugio, il grande alpinista ha realizzato e dedicato al fratello Günther, un sentiero-ferrata molto frequentato. Günther, anch’egli grande alpinista, perì a 24 anni sul Nanga Parbat. Da notare che l’altro fratello Siegfried, esperto Guida alpina, è deceduto a 35 anni colpito da un fulmine sul Catinaccio.
Le Odle appartengono alle Dolomiti che sono famose in tutto il mondo per la loro bellezza dovuta soprattutto al colore delle rocce e al prevalere di torri, bastioni, guglie e pareti verticali. Il colore varia da zona a zona, ma prevalgono i colori chiari (Monti Pallidi), mentre sulle pareti verticali o strapiombanti si ammira il caldo color rosa (Monti di Corallo). Molto frequentate, le Dolomiti conservano una grande rilevanza dal punto di vista alpinistico e non solo per la verticalità delle parerti; basti pensare che ben trenta vette superano la quota di 3.000 metri. Tra queste svetta la Marmolada, q. 3343, che è seguita dalle notissime Tofane, Pale di S. Martino e Tre Cime di Lavaredo. La punta più alta delle Odle, il Sass Rigais, raggiunge q. 3025. Studiate dal geologo francese Deodat de Gratet de Dolomieu, sono formate prevalentemente da calcare (carbonato di calcio) e dolomite (dal nome dello studioso), minerale, questo, composto di carbonato doppio di calcio e magnesio. Vi sono altre formazioni quali tufi, arenarie e, nella zona di Bolzano, una piattaforma porfirica denominata piastrone porfirico atesino.
La bellezza e la peculiarità delle Dolomiti sono completate dalla flora particolarmente ricca e rigogliosa anche per la presenza di acqua in quantità elevata.
Il Commerciante Franz Schlüter
Nell’anno 1896 il ricco commerciante di Dresda acquistò da un agricoltore di S. Maddalena un appezzamento di terreno sull’Alpe di Caseril, a quota 2301 e diede inizio alla realizzazione della struttura. La posizione era stata ponderata e prescelta su parere di alcuni alpinisti, in particolare del grande alpinista di Bolzano, Johann Santner, profondo conoscitore della zona, che naturalmente aveva valutato anche gli aspetti della sicurezza e delle comunicazioni con le valli limitrofe. Il 4 agosto 1898 il rifugio, denominato Schlüterhütte, fu inaugurato alla presenza di numerosi ospiti e valligiani e del Parroco di Funes. lI 6 agosto ebbe luogo l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle Autorità e invitati, nel corso della quale, l’edificio fu donato alla sezione di Dresda del Deutscher und Österreichischer Alpenverein, rappresentata dal presidente e fondatore, il Giudice Adolf Munkel. La nuova struttura ricettiva attirò molti appassionati della montagna, anche perché nel frattempo erano sorti altri rifugi in zone circonvicine, quali il Plose, il Firenze, il Puez. Nel 1907 fu deciso un notevole ampliamento su progetto dell’architetto Reuter il cui disegno è ancora oggi conservato nell’Ufficio Catasto di Chiusa. Il progetto rispecchia l’ambizione e le disponibilità finanziarie della sezione: tre piani fuori terra, 62 posti letto, numerosi in camere singole e matrimoniali, illuminazione a gas dei locali comuni, e acqua potabile in cucina e nei bagni; il tutto in quasi quattro mila metri cubi di costruzione che ha la conformazione di un albergo. I lavori iniziarono nel 1907 e furono ultimati già nell’anno successivo. La struttura rispondeva a tutte le esigenze degli alpinisti: base per le ascensioni, meta delle gite giornaliere, tappa dei percorsi escursionistici e sci-alpinistici a lungo raggio, soggiorno in alta quota e, inizialmente, anche centro per lo sci da discesa. Vennero anche costruiti i sentieri di collegamento. In particolare fu realizzato un percorso panoramico e suggestivo (il sentiero Adolf Munkel) che inizia dal rifugio e attraversa tutta la base delle Odle fino al rifugio Brogles. Oggi al rifugio si incrociano le alte vie numero due e numero otto delle Dolomiti.
Le guerre
La guerra 1914-18 congelò l’attività degli alpinisti e del rifugio che subì abbandono, saccheggi e vandalismi. Al termine della prima guerra mondiale, anche se il trattato di St. Germain non prevedeva nulla in proposito, i rifugi alpini di proprietà delle sezioni alpinistiche austriache e tedesche furono confiscati dallo Stato italiano e destinati alla difesa dei confini. La sezione dell’Alpenverein di Dresda perse oltre al Genova anche il Pradidali, il Treviso e il rifugio Corsi in VaI Martello. lì Club Alpino Italiano, dopo insistente richiesta e ferma restando la destinazione, ne ottenne in concessione un gran numero e, tramite un’apposita commissione, prowide alle necessarie ingenti riparazioni, acquisto di mobili, arredi e suppellettili. Per questa costosa operazione fu aperta con successo una sottoscrizione per la sistemazione e l’esercizio dei rifugi nelle Terre Redente. In seguito e con gradualità gli stessi furono affidati alle sezioni del sodalizio anche molto distanti dalla provincia quali Roma, Milano, Firenze, Verona, Bergamo... La Schlüterhütte fu affidata nel 1925 alla sezione Ligure che la ribattezzò rifugio Genova al Passo Poma, per distinguerlo dal Genova al Lago Brocan (ora Bartolomeo Figari).
Con rilevante sforzo finanziario ed organizzativo, la sezione neoaffidataria provvide a completare la dotazione dell’esercizio, con attrezzatura di ogni tipo: materassi, coperte, biancheria e mobili. Per il trasporto chiese ed ottenne l’intervento di mezzi dell’Esercito che concesse l’uso di autocarri e quadrupedi da soma. Da notare che alcuni mobili provenivano da una nave da crociera in disarmo. Anche in questo senso si era realizzato un collegamento mare-montagna. Né poteva mancare una gigantografia del porto che ancora fa bella mostra di sé nell’atrio.
La gestione fu affidata a Serafin Santer (da non confondere con il Santner), già gestore alla riapertura del rifugio nel 1923 e che era stato collaboratore della sezione di Dresda fin dagli inizi del secolo. Dal 1935 al 1939 gli subentrò Josef Malojer che fu altrettanto attivo e generoso nella conduzione e nel mantenimento della struttura. Il 22 agosto 1938 un avvenimento straordinario accadde nel rifugio: la signora Hilde Malojer partorì il primo figlio. Ma i venti di guerra spazzavano i monti al di qua e di là del confine. E non solo, la propaganda nazista e gli accordi tra l’Italia e la Germania fàvorirono il perpetrarsi di un evento infausto di proporzioni bibliche che colpì la popolazione di lingua tedesca della provincia di Bolzano: le opzioni. Oltre l’ottanta per cento degli aventi diritto optò forzosamente per la Germania (circa 200.000 persone) e 75.000 emigrarono effettivamente incontro a un destino condizionato negativamente dalla guerra e non solo. Tra questi il Malojer che il sei dicembre 1939, unitamente alla famiglia, lasciò il Genova e l’Italia e ottenne la cittadinanza germanica. È da ricordare che durante la gestione Malojer furono organizzati numerosi corsi sci per allievi provenienti per lo più dalla Liguria e dalla Germania. Nel gennaio 1937, ad esempio, vi parteciparono, tra gli altri, ben 75 sciatori di Bochum (Renania-Wesftalia).
Dalla Ligure al CAI BressanoneDopo la seconda guerra mondiale il nostro bel complesso, che aveva subito minori vandalismi anche per l’assidua opera di controllo di Serafin Santer, fu affidato alla sezione di Bressanone, rinata il 26 giugno 1945. Il presidente Ludovico Cappelletti chiese l’affidamento gratuito della struttura anche in considerazione che nel 1942 il CAI aveva ordinato alla Ligure di consegnarla alla sezione di Bolzano! Dopo una breve trattativa si arrivò ad una convenzione, il cui originale, datato 27 maggio 1946, è conservato agli atti del CAI Bressanone, e prevede il parziale rimborso delle spese sostenute per le riparazioni e l’arredamento della struttura. La somma pattuita ammontava a 130.000 lire da corrispondere in cinque rate.
|
Nell’accordo è previsto l’obbligo del mantenimento della denominazione. Già nello stesso anno e per alcuni mesi del 1947 il rifugio fu affidato al Santer, che durante l’estate dovette però lasciare l’attività a causa della malattia della moglie. Dopo una breve parentesi di Josef Profanter, subentrò Arialdo Manfredi (l’unico di lingua italiana), che con l’aiuto della signora Josephine, si dimostrò serio laborioso e capace. Nonostante le difficoltà del dopoguerra, l’attività del Genova progredì lentamente, con qualche oscillazione, ma incessantemente attirando sempre un maggior numero di alpinisti. Nel 1950 subentrò Johann lnnerkofler che riscosse l’approvazione della sezione per ben 13 anni. Dal 1964 a tutt’oggi la gestione è condotta in modo ottimale dalla famiglia Messner, prima con Anton e la signora Catharina e dal 1994 con il figlio Günther e la signora Marlene.
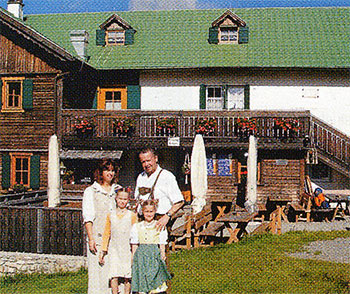 L'attuale gestore Günter Messner con famiglia davanti al rifugio.
Come già detto, il Genova era stato relativamente rispettato durante l’ultima guerra, tuttavia il passar del tempo e le intemperie dell’alta montagna avevano prodotto numerosi deterioramenti al tetto, ai serramenti, ai pavimenti, agli arredi e ad alcuni impianti. Aggiungendo a questo elenco l’acquisto di coperte, lenzuola, materassi e altri materiali necessari, il totale della spesa ammontava a tre milioni di lire. Le riparazioni furono parzialmente finanziate dallo Stato. Con il nuovo statuto di autonomia, entrato in vigore il 20 gennaio 1972, le competenze in materia di turismo sono state assunte dalla Provincia Autonoma di Bolzano.
La sezione di Bressanone.
La sezione di Bressanone, sempre molto legata al Genova, ha curato con particolare attenzione il rifugio stesso, sia con opere e fornitura di materiale che frequentando e promuovendone con successo la conoscenza e la frequenza. Nel 1986 la costruzione è stata oggetto di un intervento fatto personalmente da un gruppo di Soci che ha lavorato gratuitamente per 15 giorni e ha effettuato l’intonacatura e la tinteggiatura esterne dell’intera costruzione. Negli ultimi anni del secolo scorso sono entrate in vigore nuove e importanti norme sull’igiene e sicurezza delle strutture ricettive. Anche nel Genova furono eseguiti lavori di ammodernamento e abbellimento. In particolare fu curata la cucina con l’installazione di attrezzature di acciaio inossidabile. Si è poi provveduto all’installazione di impianti antincendio e all’apertura delle uscite di sicurezza che hanno comportato anche rilevanti lavori strutturali. È stato quindi realizzato l’impianto di depurazione delle acque reflue. Contemporaneamente fu rifatto l’acquedotto comprese le opere di captazione e potenziatì e ammodernati i servizi igienici. Inoltre sono stati risanati in maniera ottimale gli scantinati, dove è stato anche ampliato il locale invernale. Nel 1995 il CNR ha donato al rifugio un impianto fotovoltaico completo di batterie e di convertitore che produce quattro Kw/h. Numerose sono state le manifestazioni, corsi e gite organizzate al rifugio per propri Soci e, in misura minore per quelli di tutto il CAI Alto Adige. In occasione dei festeggiamenti per il 70° compleanno della sezione, nel 1994, vi è stato organizzato un riuscitissimo raduno dei soci che hanno effettuato un’ascensione di massa al Sasso di Putia (q.2875), mentre un gruppo di tre cordate ne scalava la parete nord. Nel corso dei decenni di attività, il rifugio è stato meta di numerose personalità politiche, militari, religiose e grandi alpinisti. Merita particolare menzione il presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini che ha pranzato con soddisfazione nella sala da pranzo e ha annotato e firmato il registro degli ospiti: “abbiamo mangiato e siamo stati sereni in questo accogliente rifugio. Fervidi auguri”. Sandro Pertini 31 VIII 1983.
Il centenario del rifugio.
Nell’anno 1998 in occasione del primo centenario dell’opera, la sezione di Bressanone del CAI ha organizzato i festeggiamenti al rifugio con un afflusso di Soci e invitati particolarmente numeroso. Tra le Autorità: il sindaco di Funes Runggatscher, il vicesindaco di Bressanone Dario Stabìum, il presidente della Ligure Lorenzo Bonacini, il vicepresidente della sezione di Dresda Josef Fais e il presidente generale Roberto De Martin. Ha fatto gli onori di casa il presidente Annibale Santini, che ha anche pronunciato il discorso ufficiale. Era presente una rappresentanza della sezione di Dresda, del CAI Alto Adige e di numerose sezioni alpinistiche anche di lingua tedesca. La manifestazione comprendeva: S. Messa, discorsi celebrativi, esibizioni del Coro Plose del CAI Bressanone, diretto dal M.° Ilario Sedrani, della Banda musicale di Funes (M.° Profanter) nonché dimostrazione del soccorso alpino del CAI Bressanone diretta da Paolo Sferco con il recupero con l’elicottero di un presunto ferito.
 Il Genova durante i festeggiamenti del centenario.
Il giorno precedente in una sala di Bressanone, alla presenza di un selezionato pubblico e naturalmente numerose Autorità, la sezione ha presentato il libro “Rifugio Genova -Schlüterhütte” scritto dal compianto Socio, giornalista e scrittore Fausto Ruggera.
 1998: i discorsi celebrativi del centenario; da sx Josef Fais di Dresda, G. Bonacini di Genova e A. Santini di Bressanone.
Lo scrivente, prima di cessare dalla carica di presidente sezionale e in previsione dei festeggiamenti, gli aveva affidato l’incarico di realizzare l’opera e aveva ricercato numerosi documenti e fonti di consultazione. Le presentazioni dell’opera contengono anche un saluto e un augurio del presidente della Sezione di Dresda, Ludwig Gedicke, sezione che dopo la seconda guerra mondiale aveva trasferito la sede a Böbìingen nella Repubblica Federale Tedesca. Tra l’altro, vi è riprodotta la fotografia della cerimonia di gemellaggio tra le sezioni Bressanone e Ligure, effettuata il 10 luglio 1994 sulla cima del Sass Putia e perfezionata vicino al rifugio. Alla presenza del presidente generale Roberto De Martin, i presidenti Vittorio Pacati e Giancarlo Nardi hanno suggellato il gemellaggio con parole di circostanza e la consegna delle rispettive targhe. lì libro del centenario, bilingue e corredato da numerosa documentazione fotografica, è acquistabile unicamente nel rifugio e nella sede del CAI Bressanone.
Il futuro.
Il decreto legislativo 21 dicembre 1998 numero 495 ha disposto il passaggio della proprietà dei rifugi alpini già delle Sezioni alpinistiche austriache e germaniche, dallo Stato alla Provincia Autonoma di Bolzano. La concessione degli stessi al Club Alpino Italiano è tuttavia prorogata fino aI 31 dicembre dell’anno 2010.
Naturalmente anche il Genova al Passo Poma segue la stessa sorte e ancora non si sa come sarà amministrato. Nonostante questo, è però evidente che gli eventi succedutisi dopo l’ultima guerra mondiale ci inducono all’ottimismo sul futuro di questa terra e del rifugio stesso. Esprimo l’augurio che la casa degli alpinisti di fronte alle Odle, nata quasi 110 anni fa con un atto di grande generosità e amministrata, in periodi successivi, dagli alpinisti di Dresda, di Genova e Bressanone, rimanga sempre simbolo e luogo d’incontro fra le genti per la diffusione degli ideali di amicizia e fraternità che caratterizzano e uniscono gli alpinisti di tutto il mondo.
Vittorio Pacati Bressanone, novembre 2007
L’autore. Nato a Valbondione (BG) nel 1933, è ufficiale degli Alpini a riposo e vive a Bressanone. È stato presidente della locale sezione CAI per 8 anni. Dopo numerosi incarichi nel CAI Alto Adige e nel Convegno è stato eletto Consigliere Centrale nel 2004. Per contattarlo: pacvit3@ailceposta.it. Il suo sito personale è visitabile con http://www.vittoriopacati.it
RECAPITI: tel. del rifugio 0472 840132; deI Gestore 0472840389(S. Maddalena. in Funes}. ACCESSI: da Campilì di VaI Longiarù, laterale della VaI Badia (2 ore), segnavia n. 4; dal Passo delle Erbe (2,5 ore) , segnavia n. 8; da Malga Zannes in VaI di Funes (2 ore) segnavia n° 32 e 33 (è l’accesso più usato); oppure percorrendo l’alta via n. 2 e n. 8 delle Dolomiti. TRAVERSATE: rifugio Plose ore 2, rifugio Puez ore 4,30, rifugio Firenze ore 3. ASCENSIONI: Sass Putia, Monte Tullo; più distanti, le Odle. VARIE: L’alta via delle Dolomiti n. 2 inizia a Bressanone e termina a Feltre. È suddivisa in 13 tappe e comprende numerose varianti. Le montagne più belle e famose che si incontrano nel percorso sono Puez-Odle, Gruppo del Sella (in particolare si passa dal passo Gardena e dal passo Pordoi), Marmolada e le Pale di S. Martino (si transita dai passi Rolle e S. Pellegrino). La via è stata prolungata da Innsbruck a Bressanone con 9 tappe e si chiama via Europea perché transita dal rifugio Europa (ex Venna alla Gerla). L’alta via n. 8 delle Dolomiti inizia a Bressanone e termina a Salorno. È suddivisa in 10 tappe e comprende alcune varianti. Fino al rifugio Genova coincide con la n.2. Il sentiero Adolf Munkel inizia dal rifugio Genova e percorre per tutta la lunghezza la base delle Odle fino al rifugio Brogles. Il sentiero-ferrata Günther Messner (Günther Messner Steig o GM) inizia alla croce Russis (CoI Rodella) sulla strada Funes-Passo delle Erbe e termina 700 metri oltre. CARTOGRAFIA Kompass. 56 Bressanone. lnterreg III Italia - Austria. BIBLIOGRAFIE: Ed. Manlrini: i rifugi alpini dell’Alto Adige di W. Dondio, 1988: Ed. Sez. Bressanone del CAI AA: 100 anni Rifugio Genova di F. Ruggera, 1993. Ed. Sez. Bressanone del CA AA: Montagne senza confini di F. Ruggera, 1994. Ed. Provincia Autonoma Bolzano: Problemi dell’Autonomia della Provincia di Bolzano, 1989.
Pubblicato su "La Rivista, bimestrale del Club Alpino Italiano", novembre-dicembre 2007
|
I rifugi storici del CAI (2)
È viennese di nascita il
"RIFUGIO PONTE DI GHIACCIO"
- nel 2008 ricorre il centenario dell'inaugurazione. -
Il rifugio Passo Ponte di Ghiaccio (in tedesco Edeirautehütte o Eisbruggjochhütte) sorge sul passo omonimo che unisce la Val di Fundres e la Valle Selva dei Molini a quota 2545 sulle Alpi Aurine, in provincia di Bolzano.
L’ associazione di Vienna “Edelraute” che l’ha costruito nel 1908 ha il nome di una pianta officinale d’alta montagna, 1’ Artemisia glacialis, che in Italia è conosciuta con un nome di origine francese: Genepì dei ghiacciai.

Il rif. Ponte di Ghiaccio (a destra), il Miglioranza (a sinistra)
Il Rifugio Edelraute.
L’Associazione Edelraute di Vienna (Alpine Gesellschaft Edelraute des Österreichischer Alpenclubs) ha costruito il rifugio e dopo pochi anni èconfluita nella sezione di Vienna dell’Alpenclub. Non sono giunte fino a noi altre notizie certe.
La sezione di Vienna dell’ Österreichischer Alpenclub fu fondata nel 1862 ed è stata una delle prime di tutto l’impero Austro-Ungarico e del mondo tedesco. Solo nel 1869, infatti, nacque a Monaco l’analoga associazione tedesca che, dopo lunghe trattative, nel 1874 si fuse con l’austriaca nel Deutscher und Österreichischer Alpenverein (Associazione Alpinistica Tedesca e Austriaca) con sede a Monaco di Baviera.
Il Ponte di Ghiaccio fu edificato dopo la rinuncia della sezione di Berlino che aveva accarezzato l’idea di realizzare una costruzione in zona già dal 1899. La costruzione, interamente in legno ad eccezione delle fondamenta che superavano di pochi centimetri il livello del terreno, si componeva di una minuscola cantina, di una cucina, due stanze per il gestore e di una sala con al centro una stufa a legna. Dall’ingresso una scala portava al piano superiore composto dai servizi e da quattro stanzette con 21 posti letto. Il tutto non raggiungeva i 400 metri cubi di costruzione.
La struttura ricettiva si inserì opportunamente al centro del percorso tra il Wienerhütte (sarà rif. Monza dal 1925) realizzato ai piedi del Gran Pilastro dall’Alpenclub di Vienna nel 1881 e il Nevesjochhütte (ora G. Porro) costruito dalla sezione di Campo Tures del DÖAV nel 1880 e ricostruito nel 1895 dalla sezione di Chemnitz. Sono collegati dal sentiero n. 1 attraverso la vedretta del Gran Pilastro, il passo di Punta Bianca e l’alta via di Neves. L’Edelrauthütte fu inaugurato festosamente il 17 agosto 1908, ma era in funzione e gestito dai coniugi Anna e Alois Unterkircher di Fundres, già dal 1907.
Alla cerimonia di inaugurazione presenziò il rappresentante dell’ Imperatore Francesco Giuseppe, il dr. Josef Daimer, originario di Vienna, ma molto affezionato a Campo Tures.
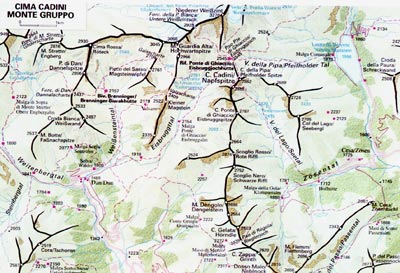
Localizzazione del rifugio nella cartina GMI - Alpi Aurine - CAI-TCI, 2002
Le Alpi Aurine...
Tutte le montagne sono belle per gli Alpinisti, ma qui si respira aria da grandi imprese. Le cime sono di notevole altitudine e vi è un vasto ghiacciaio che si estende prevalentemente in Austria dall’alta VaI di Vizze, sotto il Gran Pilastro, fino oltre il Monte Lovello (Grosser Löffler, q. 3376) passando dal Mesule, Cima di Campo e Sasso Nero, tutte vette oltre i 3300 metri di quota, lungo il confine Italo-Austriaco che corrisponde alla displuviale nord della Valle Aurina. A conferma del grande interesse alpinistico ed escursionistico che queste montagne suscitano, è da rilevare che dal rifugio ora passano l’Alta Via Alpina, l’Alta Via di Fundres e l’Alta Via di Stabeler, che qui inizia. Oltre il confine vi è il sentiero n. 02, delle Alpi Centrali che è uno dei dieci sentieri a lunga percorrenza dell’Austria. Nel 1986, in sostituzione del rifugio Monza, completamente distrutto nel 1965 da un attentato (o, forse, da una slavina), è stato costruito il rifugio Gran Pilastro (Hochfeilerhütte) dalla sezione di Vipiteno dell‘Alpenverein Südtirol (Associazione di lingua tedesca dell’Alto Adige). La nuova struttura ha contribuito ad incentivare il flusso turistico-alpinistico anche per il Ponte di Ghiaccio. Dal nostro rifugio, che è di grande interesse alpinistico, sono possibili le salite al Gran Pilastro q. 3509, alla Punta Bianca q. 3371, e ad altre numerose ed interessanti cime. Oltre a questo, vi sono bellissime traversate, paesaggi ammirevoli, molti laghetti alpini e splendide varietà di fiori di montagna quali Dafne striata, Stella alpina, Genziana puntata, Nigritella, Amica e rododendri; inoltre vi sono numerosi rifugi e boschi meravigliosi con abete rosso, larice e pino cembro. Tra i fiori è da annoverare logicamente l’Artemisia glacialis (Genepì dei ghiacciai). Dell’Artemisia, che appartiene alla famiglia delle Asteracee, se ne conoscono diverse specie (verlotorum, laxa, mutellina ecc.). In queste zone non è radicata la tradizione di utilizzarla per la preparazione di liquori; naturalmente ora men che meno tenuto conto delle norme molto restrittive a tutela della flora particolare. Le rocce sono prevalentemente gneiss per cui è facile trovare minerali pregiati quali l’adularia (varietà limpida dell’ortoclasio rinvenibile proprio negli gneiss) quarzo affumicato e l’apatite di diverse forme e colori.
Sì incontrano varie specie di animali: fino a due mila metri di altitudine i caprioli, e poi camosci e stambecchi che all‘escursionista disattento possono passare inosservati. Non così la marmotta di guardia al branco che con un forte e caratteristico grido suona “l’attenti” al sopraggiungere dell’uomo e lo osserva poi, ritta sui posteriori, fino a quando non è vicino. È anche possibile vedere pernici bianche e lepri bianche.
...e le sue valli.
La Valle Selva dei Molini è un Comune di 1500 abitanti composto da due abitati principali (Selva e Lappago) e numerose piccole frazioni. La Valle Aurina comprende Lutago, Riobianco, S. Giovanni, Cadipietra, S. Giacomo e S. Pietro riuniti dal 1929 in unico Comune di quasi sei mila abitanti. All’ingresso della valle vi è l’imponente e rinomato Castello di Tures risalente al 1250 che è uno dei meglio conservati di tutto il Tirolo ed è visitabile tutto l’anno, ad eccezione del mese di novembre. Molto interessanti sono anche il Museo minerario di Cadipietra con numerosi attrezzi e oggetti concernenti l’attività mineraria, il Museo privato dei Minerali a S. Giovanni e, a Lutago, il Museo dei Presepi. Predoi è un piccolo Comune di poco più di 600 abitanti che si estende fino alla Vetta d’Italia e comprende le antiche miniere di rame chiuse definitivamente nel 1971; interessante è l’area museale distaccata di Predoi del Museo Provinciale delle Miniere che offre la possibilità dì entrare per 1100 m. nella galleria di S. Ignazio con il trenino. Nel Comune e in tutta la Valle è molto diffusa la lavorazione del pizzo a tombolo, introdotta in Valle da un sacerdote tedesco originario dei Sudeti, alla fine del secolo 19°, nel periodo in cui era sospesa l’estrazione e la lavorazione del rame. A Predoi vi è un Ufficio informazioni del Parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina che comprende i Comuni di Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Gais, Perca e Rasun-Anterselva. Ambedue le Valli sono molto frequentate e attrezzate soprattutto per il turismo estivo. A Lutago vi è la stazione sciistica di Monte Spicco. A Cadipietra la cabinovia di Cima Chiusetta (Klausberg). Sono relativamente numerosi gli itinerari sci-alpinistici segnati sulla carta. In particolare si segnala il percorso Lappago-Lago di Neves-Rifugio Ponte di Ghiaccio-Punta Bianca. Oltre al turismo è ancora molto diffuso e redditizio l’allevamento del bestiame favorito dalle norme sul Maso Chiuso che vieta il frazionamento della proprietà terriera e attribuisce il diritto di proprietà per successione al figlio primogenito; da pochi anni il diritto è stato riconosciuto anche alla figlia primogenita. Da notare che ancora oggi gli agricoltori sono proprietari di malghe e terreni oltre frontiera. Ogni estate il bestiame è condotto all’alpeggio sui pascoli dello ZillertaI in Austria; le mandrie varcano il confine sul passo del Cane q. 2557, sul Giogo del Cornetto q. 2553 o percorrendo altri itinerari. Molto praticato è anche l’artigianato artistico soprattutto del legno, con particolare riferimento a statue, oggettistica e maschere di carnevale. Ovunque si incontrano pensioni e alberghi lindi, attraenti e ben organizzati. Notevoli sono anche alcune delle numerose chiese, tutte ben tenute, che conservano tesori d’arte pittorica e scultorea. La più antica è la chiesa di S. Spirito di Casere-Prato Magno in stile gotico risalente al 15° secolo. Nel 1996 sono stati festeggiati i 500 anni della chiesa gotica di Lutago. A S. Giovanni vi è una bella chiesa barocca del 18° secolo.
La Sezione di Bressanone e il suo rifugio.
La sezione di Bressanone è sempre stata affezionata in modo particolare al Ponte di Ghiaccio, vi ha realizzato numerose opere e l’ha frequentato e ne ha promosso e diffuso la conoscenza. Al termine della prima guerra mondiale i rifugi alpini delle “Nuove Provincie”di proprietà delle sezioni alpinistiche austriache e tedesche passarono in proprietà allo Stato e destinati alla difesa dei confini. Il Club Alpino Italiano, chiese inutilmente di subentrare al DÖAV nella proprietà di tutti i rifugi confiscati; dopo il diniego e dopo molte insistenze, e ferma restando la destinazione, ne ottenne in concessione trentennale un gran numero. Per le necessarie ingenti riparazioni, acquisto di mobili, arredi e suppellettili, aprì con successo una pubblica sottoscrizione per la sistemazione e l’esercizio dei rifugi nelle Terre Redente. Nel 1925 il nostro rifugio fu affidato alla sezione di Bressanone, fondata l’anno prima e presieduta dall’Avv. Augusto Cesa-Bianchi di origine milanese (fratello del dott. Domenico, Archiatra Pontificio). La gestione fu data, prima a Paul Reichegger di Lappago, poi per due anni a Franz Knollseisen, cui subentrò, per dieci anni, la signora Magdalena Uhrer con la collaborazione dei figli Paula e Sepp. A fianco dell’edificio vi era un rustico adibito a deposito materiali e al ricovero di un gruppetto di capre che fornivano il latte e la carne per il rifugio, integrando così i magri proventi dello stesso. I rifornimenti avvenivano da Fundres e con circa 4 ore di marcia. Solo dopo la realizzazione della diga di Neves negli anni ‘60 fu costruita la rotabile fino alla Malga Comunale di q. 1878 e reso più conveniente effettuare i rifornimenti dalla Valle Selva dei Molini. Dopo la seconda guerra mondiale, il Club Alpino Italiano chiese di ottenere la proprietà dei rifugi già precedentemente in concessione, ma il Ministero della Difesa-Esercito con dispaccio 21825/D in data 25 ottobre 1949 rispose negativamente per la seconda volta e contemporaneamente autorizzò il rinnovo della concessione per 29 anni a partire dalla data delle singole convenzioni da sottoscrivere. Con rogito n. 14321 in data 28 giugno 1955, il Presidente del CAI Bartolomeo Figari sottoscrisse la concessione in uso del “rifugio militare Passo Ponte di Ghiaccio” per un affitto annuo simbolico di mille lire. Dei 42 rifugi dislocati nella Provincia di Bolzano solo sei o sette sono stati risparmiati dai saccheggi e devastazioni operate dalle truppe in ritirata e dai soliti vandali locali. Anche il nostro era gravemente danneggiato e fatiscente; infatti, oltre alle ingiurie del tempo, i saccheggiatori l’avevano svuotato, asportato molti infissi, rendendolo così inabitabile e irriconoscibile. Per la ricostruzione e l’arredamento fu preventivata una spesa di un milione e seicentomila lire, che era una somma rilevante, in parte coperta con pubblici finanziamenti. La sezione operò con impegno e passione conseguendo esaltanti risultati, sia nei lavori di ricostruzione che nel promuoverne l’attività, cosicché negli anni successivi e gradualmente fu frequentato sempre in misura maggiore. La gestione fu affidata nel 1946 a Mìchael Ebner di Fundres cui subentrarono i coniugi Adelheid e Sepp Volgger per otto anni e poi Peter Volgger fino al 1960. Nel 1960 e fino al 1972 la struttura fu requisita da Ministero Difesa per esigenze di ordine pubblico e adibita a casermetta per un presidio di Alpini addetti al controllo della fascia confinaria. In tutta la Provincia era in atto un programma di controllo del territorio e di repressione degli attentati finalizzati ad ottenere una maggior autonomia per la Provincia di Bolzano. Dopo la riconsegna, furono necessari nuovi lavori e nuovi arredi che, pur finanziati dall’Ente pubblico, comportarono ulteriori impegni e lavoro per la sezione. Nel 1973 la conduzione fu affidata ad Anton Weissteiner in società per alcuni anni con Josef Mittermair, ambedue maestri in pensione di Vandoies.
Successivamente Il Weissteiner proseguì da solo con il rilevante apporto della signora Maria. Nel prossimo anno compirà meritatamente e con onore i 35 anni di permanenza nel rifugio. Da notare che ha sempre portato a spalla con la gerla, i viveri freschi dal lago di Neves al rifugio.Ultimamente è affiancato nei mesi estivi dal figlio Michael Josef, insegnante di scienze motorie.
|
Nel 1960 e fino al 1972 la struttura fu requisita da Ministero Difesa per esigenze di ordine pubblico e adibita a casermetta per un presidio di Alpini addetti al controllo della fascia confinaria. In tutta la Provincia era in atto un programma di controllo del territorio e di repressione degli attentati finalizzati ad ottenere una maggior autonomia per la Provincia di Bolzano. Dopo la riconsegna, furono necessari nuovi lavori e nuovi arredi che, pur finanziati dall’Ente pubblico, comportarono ulteriori impegni e lavoro per la sezione.
Nel 1973 la conduzione fu affidata ad Anton Weissteiner in società per alcuni anni con Josef Mittermair, ambedue maestri in pensione di Vandoies.
Successivamente Il Weissteiner proseguì da solo con il rilevante apporto della signora Maria. Nel prossimo anno compirà meritatamente e con onore i 35 anni di permanenza nel rifugio. Da notare che ha sempre portato a spalla con la gerla, i viveri freschi dal lago di Neves al rifugio.Ultimamente è affiancato nei mesi estivi dal figlio Michael Josef, insegnante di scienze motorie.

Il rifugio Ponte di ghiaccio fino al 1975
Il “Miglioranza” e l’ampliamento del rifugio.
Al termine del periodo degli attentati e dopo l’approvazione della nuova legge costituzionale, in vigore dal 20 gennaio
1972, per effetto della quale la Provincia Autonoma di Bolzano ottenne ampia autonomia legislativa e amministrativa, le montagne dell’Alto Adige furono frequentate sempre in misura maggiore. Il piccolo rifugio si dimostrò assolutamente insufficiente, soprattutto per i servizi igienici e per i posti letto. Con un programma ardito la sezione progettò e costruì un vero e proprio rifugio in muratura a fianco dell’edificio principale. Al pian terreno furono ricavati una cucina, un servizio e due stanze da letto e, al piano superiore, una camerata per un totale di 29 posti letto. Il piano terra costituisce il locale invernale. È doveroso registrare che quest’opera, ideata dalla squadra del CNSAS durante la presidenza del dr. Remo Letrari, fu realizzata con le donazioni di materiali edili da parte dei Soci e dei Simpatizzanti di Bressanone, opportunamente motivati e sollecitati dal nuovo Presidente Lino Franchini. Un gruppo di Soci della sezione provvide, soprattutto con lavoro volontario durato due stagioni estive, a realizzare la costruzione seguendo le direttive di un provetto muratore e di un bravo carpentiere. I soci erano principalmente i 15 componenti della squadra di soccorso alpino diretta dal caposquadra Giorgio Zanesco; per il particolare impegno e frequenza sono da citare Marcello Parisi, Franco Titton e Silvano Zucchelli. Il trasporto dei materiali fu effettuato con l’elicottero e con le Salmerie della Brigata Alpina Tridentina, che intervennero massicciamente a favore del CAI per l’ennesima volta. La nuova costruzione fu inaugurata il 14 settembre 1980 e intitolata ad Enzo Miglioranza, socio dell‘alpinismo giovanile del CAI Bressanone, deceduto tragicamente il 5 maggio 1979 nella palestra di roccia di La Mara. L’evento aveva suscitato enorme impressione nella città e costernazione e dolore nella famiglia e nella più grande famiglia del CAI che promise di non dimenticarlo. E mantenne la promessa. Per quest’opera, frutto di uno slancio di generosità dell’intera sezione, e sicuramente necessario citare e ringraziare i miei predecessori, Gianfranco Titton e Vinicio Sarti, succedutisi alla presidenza della sezione durante i lavori, l’ispettore Franz Wierer e il gestore Anton Weissteiner. Si alternarono nel lavoro molti altri soci e tutti gratuitamente. E impossibile citarli tutti, è però necessario ricordare il padre di Enzo, l’accompagnatore di AG Corrado Miglioranza che si è dedicato nel lavoro con impegno e generosità. Negli anni successivi fu realizzato un avancorpo del rifugio per ricavare servizi igienici e deposito zaini, un nuovo acquedotto, una centralina idroelettrica, il depuratore delle acque reflue e la piazzola per l’atterraggio dell’elicottero. Infine, con un’opera veramente rilevante, è stata ampliata la cucina e la
sala da pranzo. Quest’ultimo intervento è stato realizzato su terreno ceduto in uso dalla Comune e con regolare concessione edilizia intestata al CAI Bressanone, ma con il lavoro, encomiabilmente rilevante e molte spese a carico del gestore Anton Weissteiner.
La frequentazione.
La frequentazione di questa parte delle Alpi Noriche, più comunemente dette Aurine, e quindi del rifugio, è sempre molto alta da parte degli escursionisti, degli alpinisti e degli scialpinisti. Meritano particolare menzione gli escursionisti giornalieri provenienti da Selva dei Molini e da Fundres. I sentieri sono facilmente percorribili e adatti a scolaresche, gruppi di alpinismo giovanile e di gruppi famigliari. Si sottolinea una sola precauzione in caso di neve; nella Valle della Pipa, sopra il lago della diga di Neves, è necessario percorrere il sentiero invernale sul costone nord, perché dai pendii sulla destra idrografica possono staccarsi delle piccole slavine. Naturalmente dal rifugio sono transitate Autorità e alpinisti di fama, molto spesso in incognito. Ricordiamo il Presidente del CAI Roberto De Martin e il Socio onorario del CAI, Reinhold Messner che lo visitò più volte e, in un’occasione, vi organizzò un raduno di lavoro al quale parteciparono personalità tedesche dell’alta finanza e delle assicurazioni con la presenza di giornalisti di Burda Verlag. Nel 1986 e per diverse settimane, il rifugio conobbe un visitatore particolarmente attento. Era un laureando in ingegneria che studiava, misurava e prendeva nota di tutto. Il dr. Maurizio Staglianò di Bressanone si è laureato, appunto in ingegneria, discutendo la sua tesi sul rifugio Ponte di Ghiaccio. La tesi ipotizzava la realizzazione di una struttura seminterrata a valenza bioarchitettonica e la conservazione dell’edificio esistente, considerato di un certo valore paesaggistico e storico. Nel 1996 il rifugio ebbe la visita di un folto gruppo di Soci del CAI di Fiume accompagnati dal Presidente Generale De Martin e dallo scrivente, Il Ponte di Ghiaccio è stato occasione e testimone del gemellaggio tra la sezione di Fiume (in esilio) e quella di Bressanone. La cerimonia fu poi ripetuta a Bressanone dopo l’assemblea. Nel 1994 il CAI Bressanone, in occasione del 70° anniversario della costituzione, organizzò tre raduni sezionali nei propri rifugi; al Ponte di Ghiaccio-Enzo Miglioranza il raduno ebbe per tema la Commemorazione dei Caduti della montagna. Durante una commovente cerimonia religiosa, è stata installata su un’apposita torretta di legno e benedetta una campana donata da Corrado Miglioranza e dedicata a tutti i Caduti della montagna. Ancora oggi la campana, dal tetto della costruzione dedicata al nostro Enzo, diffonde tra le rocce la sua voce di preghiera e di ricordo per onorare il sacrificio di tutti coloro che sulle rocce hanno perso la vita.

L'edificio con il gruppo del CAI Fiume.
Stato attuale.
Nel 1996, durante l’escursione con i Soci del CAI di Fiume, il presidente generale dei CAI, Roberto De Martin Topranin, mi disse: “Vittorio, guarda, questo rifugio è vecchio, ma è bello e tenuto molto bene; non reputo opportuno l’abbattimento per far posto ad una nuova costruzione”. -Pur non volendo, la sezione CAI di Bressanone è stata costretta a seguire l’esortazione del Presidente. Più di una volta sono stati esaminati, programmati e progettati l’abbattimento e la ricostruzione. Le difficoltà incontrate sono risultate, per ora, insormontabili. La struttura risponde ancora in maniera più che soddisfacente alle necessità degli alpinisti ed escursionisti che la utilizzano, anche se sono necessarie riparazioni sempre più frequenti. Nell’inverno 1994-95, ad esempio, il vento ha asportato completamente il tetto. Il ripristino è stato fatto con l’indennizzo dell’assicurazione e il lavoro dei volontari. E da segnalare l’impegno dei Soci Carlo Fiaschi e Renato Ferraro, ispettori cedente e subentrante che hanno portato a spalla il telo di plastica di 30 Kg. per coprire provvisoriamente la costruzione scoperchiata, dalla diga di Neves al rifugio usando le racchette da neve. La sezione di Bressanone del CAI con la collaborazione ed il patrocinio del Comune di Selva dei Molini, si appresta a celebrare e festeggiare i cento anni della relativamente piccola, ma importante struttura ricettiva alpina. La cerimonia è programmata il 13 luglio 2008 al rifugio. Farà gli onori di casa il Presidente Pietro De Zolt. Anche il Rifugio Ponte di Ghiaccio è passato in proprietà alla Provincia Autonoma di Bolzano per effetto del D.L. 495 del 21dicembre 1998, mentre il CAI ne mantiene la concessione fino al 31 dicembre 2010. Comunque evolvano le vicende politiche e amministrative, qui ci sarà sempre un rifugio che accoglie gli alpinisti e gli escursionisti; ci sarà sempre un‘Associazione Alpinistica che, unitamente ad uno dei meravigliosi Gestori, presidiano il territorio dal punto di vista ambientale e della sentieristica, distribuiscono consigli e informazioni, soccorrono gli infortunati e diffondono gli ideali di generosità, solidarietà e amicizia che caratterizzano gli Alpinisti di tutto il mondo.
Vittorio Pacati Bressanone, marzo 2008

Reinhold Messner, Hans Kammerlander con la Sig.ra Maria e il figlio Dr. Thomas.
Vittorio Pacati Bressanone, novembre 2007
Notizie pratiche . . . .
RECAPITI: tel. dei rifugio 04724 653230; deI Gestore 0474 869013 (Vandoies). Sito Internet: http://www.edelrauthuetieit.
contatto: info@edelrauthuetteit
ACCESSI: da Fundres casolari di Dan (3,5 ore), segnavia n 13; dal parcheggio vicIno alla diga di Neves (2,5 ore), segnavia n. 26; oppure percorrendo la Via Alpina, o l’Alta via di Neves, l’Alta via di Fundres, o ancora l’Alta via di Stabeler.
TRAVERSATE: - al rifugio Gran Pilastro (Hochfeilerhùtte) ore 2.5 segnavia 1. - Nota:
dopo la diminuzione del ghiacciaio, la Vedretta Gran Pilastro si attraversa in un pianoro perciò non sono più indispensabili i ramponi e la piccozza.
AI rifugio G. Porro ore 3, segnavia 1, oppure 26 e 24.
Al rifugio Bressanone per l’Alta via di Fundres, ore 8.
Al rifugio Lago della Pausa, ore 7 (pascolo scosceso), al rif. Furtsctiaglhaus sul sentiero a lunga percorrenza 02 (Austria), ore 5 (attraversamento ghiacciaio).
ASCENSIONI: Punta Bianca 3370 m. per la Forc. Alta di Punta Bianca, ore 3, media difficoltà (corda, ramponi e piccozza).
- Gran Pilastro 3509 m. abbastanza facile, se non ghiacciato (corda ramponi piccozza), 4 ore. Monte Guardia Alta, 3045 m. 3 ore, (solo esperti).
LE ALTE VIE:
La VIA ALPINA unisce gli otto Stati di tutto l’arco alpino da Trieste a Monaco e si suddivide in 5 itinerari diversi e 341 tappe giornaliere per 5.000 Km di sentieri che non presentano difficoltà tecniche. Il rifugio Ponte di Ghiaccio è compreso nella tappa R 34 Rif. Porro - Dan di Fundres. La VIA ALPINA è stata realizzata per effetto della convenzione stipulata dagli otto Stati Alpini nel 1991. Il CAI ha contribuito alla realizzazione.
- L’Alta via Hans Stabeler unisce il rif. Ponte dì Ghiaccio al rif. Vittorio Veneto passando dal rif. Porro.
- L’Alta via di Fundres inizia da Fundres (o da Prati di Vizze) e termina a Falzes.
- L‘Alta via di Neves collega il rif. Ponte di Ghiaccio al rif. Porro.
CARTOGRAFIA
Kompass, 82 Tures - Valle Aurina.
BIBLIOGRAFIA:
Ed. Sez. Bressanone del CAI AA: Annuario 1997.
Ed. Sez. Bressanone del CAI AA: Montagne senza confini di E Ruggera,1994.
Pubblicato su "La Rivista, bimestrale del Club Alpino Italiano", marzo-aprile 2008
|
I rifugi storici del CAI (3)
IL RIFUGIO "CITTÀ DI BRESSANONE" ALLA PLOSE
- costruito dagli alpinisti di Bressanone del DÖAV nel 1887 in luogo particolarmente panoramico -
Il rifugio Città di Bressanone alla Plose (in tedesco Plosehütte) è ubicato a quota 2446 sull’Alpe della Plose, ad est di Bressanone in provincia di Bolzano.
Costruito nel 1887 dalla sezione di Bressanone del Deutscher und Österraichiscer Alpenverein, dal 1924 è di proprietà della sezione di Bressanone del Club Alpino Italiano.
Dislocato a pochi metri dalla sommità della montagna, costituisce un punto particolarmente panoramico che consente di spaziare con la vista dalle Dolomiti alle Alpi Venoste e Breonie dalle Dolomiti di Brenta, all’Ortles e all’Adamello.
A quota 2486 è possibile consultare un cerchio di orientamento con il nome delle principali cime visibili.
.

Il rif. Plose (costruzione iniziale e dopo il secondo ampliamento)
La Plose, montagna di Bressanone ricca di risorse.
Il massiccio della Plose culmina con cima Telegrafo, a q. 2486, e Forca Grande, a q. 2575, ed è circondato dalle valli Eores e Luson. Appartiene geograficamente alle Dolomiti, ma ne differisce nelle caratteristiche geologiche; la Plose, infatti, è composta prevalentemente da filladi quarzifere.
Le cinque province dell’area dolomitica e cioè Bolzano, Trento, Belluno, Pordenone e Udine hanno inoltrato la richiesta affinché le Dolomiti (per meglio dire 9 siti montuosi ben circoscritti) siano dichiarate dall’UNESCO patrimonio dell’umanità. Il progetto è nato quasi 20 anni fa e molte associazioni lo sottoscrissero Il consiglio centrale del CAI, su proposta Club Alpino Accademico Orientale del giugno del 2000, approvò unanimemente l’iniziativa.
La montagna di Bressanone è ricoperta di boschi, prati e pascoli dove prevalgono i pendii dolci e le terrazze su cui sorgono numerose frazioni: S. Andrea, S. Leonardo, Clerant, Melluno, Eores e Plancios.
Nei boschi, ben curati, crescono soprattutto l’abete rosso, il pino silvestre, il pino mugo, il larice e il pino cembro. Il pino cembro, o cirmolo, fornisce un legno a struttura omogenea, abbastanza tenero, leggermente profumato, non soggetto né alle scheggiature né all’”effetto cipolla”. E’ particolarmente idoneo alla lavorazione artistica e per il mobilio anche perché non è intaccato dai tarli.
Vi sono numerose varietà di fiori, da ricercare soprattutto in terreni non adibiti a pascolo.
Ovunque, ma in modo particolare nelle radure, cresce un sottobosco variegato con molte specie di funghi. Oltre ai funghi (che sono protetti da una legge provinciale) è possibile raccogliere lamponi, mirtilli neri e rossi. Per la protezione della flora la Provincia autonoma di Bolzano, con legge 13/1972, ha disposto il divieto di raccolta di 23 specie di fiori; il divieto per alcune specie, quali ad esempio le orchidee e le genziane, si estende a tutte le varietà nostrali. L’appassionato di fotografia naturalistica può portarne a casa le relative immagini. Delle specie non protette, è consentito raccogliere non più di dieci steli fioriferi.
La fauna molto ricca è composta di lepri, caprioli, stambecchi, camosci, scoiattoli, marmotte e numerose varietà di volatili, compresa l’aquila reale.
La Plose è percorsa da numerosi sentieri di carattere escursionistico, ma anche di relax come ad esempio la Karlspromenade, realizzata agli inizi del XX secolo in onore dell’arciduca, Karl Franz Josef (ora beato) che sarà l’ultimo imperatore austro-ungarico, sovente ospite della città.
Da segnalare l’alta via di Bressanone, l’alta via dei cirmoli, l’alta via delle Tre Cime, l’alta via n. 2 delle Dolomiti Bressanone – Feltre (detta delle leggende), e l’alta via n. 8, Bressanone – Salorno.
Il rifugio è collegato a Bressanone da una rotabile, dove è ammessa la circolazione fino a Valcroce (q. 2050). D’estate e in autunno, la Plose è molto frequentata dagli escursionisti e dagli appassionati di parapendio.
La montagna di Bressanone fornisce l’acqua per l’acquedotto comunale, per quello irriguo a pioggia e per l’imbottigliamento dell’omonima acqua minerale.
Numerosi masi (fattorie) sono dislocati sui pendii fino oltre i 1500 metri di altitudine dove è praticato soprattutto l’allevamento del bestiame per le produzioni lattiero-casearie. Anche l’esercizio dell’alpeggio è molto praticato e redditizio.
E’ conosciuta anche per la rinomata stazione sciistica che ha contribuito non poco allo sviluppo turistico della città e delle frazioni; lo stesso rifugio Plose ne beneficia. La prima sciovia risale al 1951 e fu realizzata in zona rifugio sci, seguirono altri impianti nel ‘54, ’59.
Nel 1964 fu completato, infine, il collegamento Bressanone-rifugio con due funivie e una bidonvia.Gli impianti furono rinnovati completamente negli anni ‘80.
Sulla Plose è attiva da oltre 40 anni la rinomata Scuola Sci Plose.
La stazione sciistica vanta una pista da discesa, la Trametsch, considerata la più lunga dell’Alto Adige, che in pochi minuti permette di percorrere nove chilometri e un dislivello di 1400 metri.
Bressanone città principe-vescovile del Sacro Romano Impero Germanico e centro culturale.
L’antica città di Bressanone (in latino Brixia Tyrolis o Brixina, in tedesco Brixen e in ladino Persanù), che lo scrittore Diego Valeri considera la più bella città delle Alpi Orientali, occupa l’ampia conca al centro della Val d’Isarco, a quota 559, alla confluenza dei fiumi Rienza e Isarco.
La sua storia, molto interessante, ha inizio il 13 settembre 901 quando il re dei Franchi, Ludovico IV il Fanciullo, donò al vescovo Zaccaria di Sabiona (Chiusa all’Isarco) la proprietà Prihsna, dove verso la fine dello stesso secolo fu trasferita la sede del vescovado. Nel 1027 l’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico, Corrado II il Salico, donò in feudo al vescovo le contee di Isarco e Inn. L’imperatore del S.R.I., Federico I Barbarossa, nel 1179 concesse, infine, al principato la piena sovranità sul territorio, compreso il diritto di battere moneta, di amministrare la giustizia, di sfruttare le miniere nonché di disciplinare le dogane e i mercati. Il Principe-Vescovo aveva il privilegio di partecipare alla Dieta dell’Impero; non era un Grande Elettore. Il piccolo principato-vescovile fu soppresso dall’imperatore Francesco II nel 1803, tre anni prima che il titolo di imperatore "dei Romani" fosse fatto abolire da un altro imperatore: Napoleone I.
La città di Bressanone conserva le mura medioevali e il palazzo principe-vescovile, completo di torri e una parte del fossato, che nel 1973, dopo il trasferimento della sede a Bolzano, fu destinato a museo diocesano.
Unitamente al vicino complesso di Novacella, Bressanone costituisce il maggior centro artistico e culturale dell’Alto Adige. Architettonicamente molto omogeneo e conservato, il centro storico ha un aspetto tipicamente tedesco con caratteristici Erker (sporti) vetrati, portici e merlature. Al centro vi è Piazza Duomo, dove si trova anche il municipio e la chiesa parrocchiale. Di grande importanza storica e artistica, sono il battistero di S. Giovanni con affreschi del XII e XIV secolo e il chiostro con affreschi tardo-gotici.
Il Museo Diocesano è, come detto, nello stupendo palazzo vescovile. Il magnifico cortile del tardo rinascimento ha su due lati tre ordini di logge rinascimentali con statue di imperatori, duchi e conti. All’interno, suddivisa in oltre 50 sale, una ricca esposizione di sculture, affreschi, quadri e porcellane dal romanico ai giorni nostri.
Si possono anche ammirare il tesoro del duomo e una splendida collezione di presepi con circa 10 mila statuette.
Interessanti sono anche il Museo della Farmacia e della Torre Bianca.
Oltre allo storico Studio teologico accademico, vi è la sede di Bressanone della Libera Università di Bolzano e la sede estiva dell’Università di Padova.
Nell’estate del 2008 Benedetto XVI ha scelto Bressanone per la sua breve vacanza. Il Papa è molto legato a Bressanone dove, ospite del seminario maggiore, ha trascorso diversi periodi quando era cardinale. A Rasa, piccola frazione di Naz-Sciaves, quattro chilometri ad nord della città, nacque, nel 1855, la sua nonna materna Maria Tauber Peintner.
L’abbazia agostiniana di Novacella (nel comune di Varna), fondata nel 1142 dal vescovo di Bressanone Artamanno, comprende oltre all’imponente insieme di strutture conventuali ora adibite a centro congressi e convitto, una stupenda basilica di stile rococò in struttura romanica, un chiostro gotico, una grandiosa e ricca biblioteca in stile rococò con preziosi manoscritti e incunaboli nonché una bella pinacoteca. Notevoli sono anche il giardino storico, la chiesetta fortificata, paragonabile in piccolo a Castel Sant’Angelo e la fontana con gli affreschi delle sette meraviglie del mondo; poiché la fontana è ottagonale l’autore ha inserito la riproduzione di Novacella come ottava meraviglia.
Vi è sepolto il celebre poeta, diplomatico e uomo d’arme Oswald von Wolkenstein, che progettò e diresse alcuni lavori di fortificazione del complesso in previsione di una possibile invasione da parte dei Turchi.
Attualmente Bressanone è una laboriosa città di 20 mila abitanti dediti al turismo, al commercio all’industria, all’artigianato e all’agricoltura.
Plosehütte: costruzione e primo ampliamento.
La sezione di Bressanone del Deutscher und Österraichischer Alpenverein nacque il 24 settembre 1875 durante la riunione dei fondatori nell’Hotel Elefante per iniziativa del proprietario Hans Heiss. Il successivo 4 dicembre fu eletto il primo direttivo e il primo presidente, il notaio Ferdinand Hechenberger.
L’assemblea del 24 maggio 1884 elesse il farmacista Ignaz Peer, terzo presidente in sostituzione dell’ing. Johan Merkel, approvò la costruzione del rifugio nonché l’acquisto del terreno.
Dopo tre anni di preparativi e raccolta fondi, la costruzione fu edificata in sei mesi, dopo aver ottenuto un congruo contributo dalla sede centrale di Monaco. Contemporaneamente fu realizzato il sentiero n. 4, che collega S. Andrea al nuovo manufatto.
In un’atmosfera festosa, il 7 novembre 1887 avvenne la solenne inaugurazione alla presenza di autorità, delegazioni di alpinisti di Innsbruck, Salisburgo e Lipsia e del segretario del DÖAV, Emmer. Il parroco di Eores celebrò la Messa solennizzata dal coro Männergesangverein e dalla banda di Bressanone, che eseguì anche la Plose Marsch composta per l’occasione.
Il piccolo rifugio con cucina e stube, che poteva ospitare 20 persone, fu affidato in gestione a Franz Hofer di S. Leonardo, ora frazione di Bressanone.
L’inaugurazione in pompa magna pubblicizzò l’evento, ma non bastò ad attirare i visitatori nella quantità auspicata. La realizzazione di una piccola stalla per consentire di integrare i magri proventi con l’allevamento di bestiame, non migliorò le cose; così come l’inutile susseguirsi di diversi gestori.
L’apertura nel 1898 della Schlüterhütte (ora rifugio Genova al passo Poma), che dista meno di quattro ore di marcia, inaspettatamente aumentò considerevolmente l’afflusso. Analogamente la costruzione di altre strutture ricettive, quali l’attuale Firenze e il Puez, favorì il diffondersi dell’escursionismo alpino a tappe.
Nel 1905, durante la presidenza di Ignaz Mader, medico e storico, l’assemblea dei soci deliberò l’ampliamento della struttura. Furono modernizzati i servizi igienici e realizzati nuovi locali fino a raddoppiare la capacità ricettiva.
La costruzione costò quasi 13 mila corone e 14 mila per l’ampliamento.
Da notare che la credenza di legno lavorato con una certa pretenziosità è tuttora esistente.
Il 21 luglio 1907 avvenne la festosa inaugurazione della nuova struttura preceduta, la sera del 20, da una cena nello storico Albergo Elefante.
1^ guerra mondiale e dopoguerra.
La guerra congelò tutto e causò l’abbandono e il deperimento dell’immobile.
Al termine del primo conflitto mondiale le sezioni altoatesine del DÖAV e, quindi anche quella di Bressanone, si resero indipendenti e diventarono associazioni autonome.
Le autorità italiane approvarono la loro costituzione ed il funzionamento così come la registrazione del diritto di proprietà dei rispettivi immobili.
Giova qui notare per completezza che, invece, gli oltre 30 rifugi dislocati in Provincia di Bolzano, ma di proprietà di sezioni austriache e tedesche del Deutscher und Österraichischer Alpenverein furono incamerati dal Demanio Militare, per effetto del trattato di St. Germain e destinati alla difesa dei confini.
Gradualmente ripresero le attività alpinistiche ed escursionistiche ed i rifugi furono nuovamente aperti, riorganizzati e frequentati.
L’avvento del fascismo modificò radicalmente le cose. Con il decreto n. 13165 in data 3 settembre 1923 della Prefettura di Trento, fu disposto lo scioglimento di tutte le sezioni altoatesine dell’Alpenverein. I beni di proprietà furono confiscati e passati alle nascenti sezioni del Club Alpino Italiano.
Il sindaco di Bressanone, Roman Schwaighofer, in un accorato appello alla Regia Prefettura di Trento chiese che i tre rifugi della disciolta sezione (Plose, Bressanone e Fritz Walde) fossero passati in proprietà al Comune. Dopo 15 giorni il sotto-prefetto Gottardi comunicò che l’esposto non poteva essere accolto. Aggiunse, inoltre, che lo scioglimento dell’Alpenverein e la confisca dei beni immobili di proprietà “erano stati determinati da ragioni d’interesse nazionale e di ordine pubblico”.
Nel 1973 i beni incamerati furono risarciti dallo Stato con 800 milioni di lire. In precedenza, durante le trattative per le modifiche dello Statuto del Trentino – Alto Adige, era stato chiesto all’Alpenverein Südtirol se desiderava riavere i rifugi confiscati, oppure un indennizzo. Fu scelta la seconda soluzione.
Primi anni del CAI Bressanone.
Mentre la sezione di Bolzano era stata fondata già nel 1921, le sezioni di Bressanone, Merano e Brunico furono costituite nel 1923 e i rispettivi soci tesserati dal 1924, quando il Club Alpino Italiano annoverava 71 sezioni e 33.769 soci.
Nella seduta del 12 gennaio 1924 il consiglio nazionale del CAI, deliberò di aggiungere in calce a ciascun regolamento delle sezioni altoatesine una nota “ con la quale vengono categoricamente riservati alla sede centrale ampi poteri per il caso esse avessero in ogni futuro tempo a deviare da un’attività o anche da un indirizzo indiscutibilmente nazionali”.
Pur con questa speciale tutela, mal digerita, ma mai utilizzata, il CAI Bressanone seppe galvanizzare i cittadini di Bressanone con i propri ideali e la passione per la montagna e la natura e attirò numerosi iscritti anche di lingua tedesca.
Il primo presidente fu l’avvocato Augusto Cesa Bianchi, di origine milanese, alpinista amante della montagna e dell’Alto Adige che conosceva e frequentava anche prima dell’annessione all’Italia. I suoi precedenti di diplomatico e di ufficiale gli furono sicuramente di aiuto nel difficile compito intrapreso.
La sezione ebbe in proprietà il rifugio Plose cui fu successivamente attribuito il nome di Città di Bressanone alla Plose e due piccoli rifugi Bressanone e Lago Pausa (Fritz Walde). Questi ultimi furono gestiti fino all’inizio della seconda guerra mondiale e poi abbandonati perché, durante i lunghi anni del secondo conflitto mondiale, subirono danni e razzie irreparabili.
Il rifugio di Bressanone per antonomasia, invece, è stato sempre curato con passione e impegno.
La gestione fu affidata ad Obexer di Eores di cui non si conosce il nome.
Nel 1926, su imposizione del regime, la sezione fu denominata Brennero e sull’intestazione della carta da lettere appariva il motto roboante e retorico “hucusque audita est vox tua Roma parens” (anche qui è sentita la tua voce o Roma genitrice).
Nel 1931 divenne sottosezione della sezione Alto Adige che nel 1933 riassume la denominazione di sezione di Bolzano.
Intanto la guida della sottosezione era stata affidata al dott. Orfeo Cesaro, commercialista e imprenditore di grande personalità, oltre che alpinista e amante della montagna.
Nel 1929 la gestione del rifugio fu concessa alla guida alpina Beniamino Vallazza, già gestore del rifugio Chiusa e Corno al Renon e poi, su pressione del P.N.F., dal 1936 al figlio Carlo fino al 1945. Dal 1943 al 1945 l’immobile fu requisito dai reparti nazisti.
Durante la reggenza di Cesaro ebbe inizio una fortunata tradizione che perdura tuttora, la sagra della Plose. Nella sede di Bressanone è conservato il manifesto originale della prima manifestazione nel 1931.
Ma il regime non perdonò a Cesaro di non essere “allineato” e lo destituì nella primavera del 1938, usando come pretesto l’aver proposto come idoneo a gestire il rifugio Prato Croce un candidato non fascista.
Nel 1939, pertanto, e fino al 1941 la sottosezione fu retta da Ruggero Cesellato che era impiegato comunale di Bressanone.
Crescita della sezione di Bressanone.
Il 12 agosto 1942 il presidente generale del Centro Alpinistico Italiano, Angelo Manaresi, scriveva “al fascista Amedeo Trevisan”: “ sono lieto di comunicarti che il Segretario del Partito Nazionale Fascista, su mia proposta, ha ratificato la tua nomina a presidente della sezione di Bressanone del Centro Alpinistico Italiano”. Per dare una spiegazione a tale insolito linguaggio, giova qui ricordare che il regime fascista intervenne pesantemente nei confronti del Club Alpino Italiano. Gli tolse l’autonomia mettendolo alle dipendenze del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, fece trasferire la sede da Torino a Roma (Corso Umberto, 4), trasformò la denominazione in Centro Alpinistico Italiano, modificò radicalmente lo stemma con l’inserimento del fascio e dell’aquila imperiale e, soprattutto, controllando le attività e la nomina di tutte le cariche sociali.
|
A chiusura di questa parentesi, si ricorda, infine, che il presidente del sodalizio, durante le cerimonie indossava l’uniforme di gerarca fascista.
Nel dopoguerra il CAI Bressanone si riorganizzò immediatamente e con grande determinazione. Dopo la breve presidenza di Ludovico Cappelletti (1945-46) fu eletto Marcello Refatti cui, nel gennaio 1948, subentrò il dottor Remo Letrari.
La sezione aumentò rapidamente di consistenza e di voglia di fare; numerose iniziative furono portate avanti da un folto gruppo di animatori molto attivi, convinti e appassionati. Già nel 1945 fu fondato lo Sci-CAI, il Coro Dolomiti, il Gruppo Rocciatori e, negli anni successivi, il Soccorso Alpino e cinque sottosezioni (Chiusa, Vipiteno, Brennero, Fortezza e Rio di Pusteria). Nel 1946 ottenne in affidamento il rifugio Genova, già in consegna alla sezione Ligure.
E’ di quel periodo la pubblicazione di un primo notiziario della sezione e l’organizzazione del ballo annuale del CAI, evento mondano molto atteso da diverse centinaia di partecipanti.
La lunga presidenza Letrari è da ricordare soprattutto, per la costituzione, nel 1951, del soccorso alpino, di cui fu il primo caposquadra e per l’ampliamento e l’ammodernamento del nostro rifugio.
Secondo ampliamento del rifugio e nuove attività della sezione.
Con grande impegno finanziario e organizzativo, la sezione deliberò un importante ampliamento della struttura. Numerosi erano i contrari ad una così grande spesa, tutti però concordavano che la piccola struttura era assolutamente inadeguata alle necessità legate alla futura stazione sciistica. Si decise quindi la grande impresa. Il progetto fu redatto dal geom. Vittorio De Paola, vecchio socio molto attivo. Di dimensioni quasi triplicate, nella primavera del 1964, il nuovo rifugio fu ultimato. L’ampliamento comprendeva una grande sala, numerose stanze da letto per un totale di 55 posti letto e moderni servizi. Un impianto centrale a gasolio assicurava il riscaldamento dell’intero edificio; la scorta di combustibile sufficiente a coprire il consumo di 8 mesi era garantita da due grandi serbatoi interrati. Contemporaneamente all’inaugurazione degli impianti di risalita della società Funivia Plose, anche il nostro bel complesso fu inaugurato con una grande cerimonia.
L’edificio era irriconoscibile e anche esteticamente, la struttura si presentava molto bene. Nello stesso anno fu ricostituito il Coro sezionale, tuttora esistente, con il nome Plose, diretto per oltre 30 anni da Mario Cattoi. Nel frattempo era rinato lo Sci CAI che nel 1972 divenne associazione autonoma, denominata Sci club Fana, sotto la presidenza del professor Roberto Scaggiante. Dal 1972 a Natale del 1974 ebbe vita il notiziario della sezione, Il Sentiero, scritto e “ sudato” dall’amico scrittore e giornalista Fausto Ruggera, che è “andato avanti” prematuramente, circondato dalla stima di quanti lo conobbero. Dal 1972 al 1976 è stato presidente il geom. Lino Franchini che realizzò l’acquedotto del rifugio con il determinante concorso degli alpini della compagnia genio pionieri Tridentina, Dal 1976 al 1977 fu il turno del maestro di sci e alpinista Franco Titton da sempre impegnato nel CAI, in particolare come ispettore del rifugio e componente della squadra si soccorso. Dal 1977 al 1989 la guida della sezione è stata nelle mani del dottor Vinicio Sarti distintosi soprattutto per aver curato l’alpinismo giovanile. Durante la sua presidenza è stato festeggiato il centenario del rifugio. Nel 1989, diedi la mia disponibilità e fui eletto presidente per otto anni. Consegnai il testimone al rag. Annibale Santini che nel 2007 ha passato le consegne all’attuale presidente, Pietro De Zolt.

il Presidente P. De Zolt e il Vicepresidente G. Peluso del
CAI Bressanone premiano la giovane Michela.
La storia del rifugio Città di Bressanone alla Plose è strettamente connessa con quella della sezione; i presidenti ne hanno seguito i problemi e le vicende sempre attivamente e in prima persona, con la passione e l’impegno riservato alle cose importanti che sono una parte della nostra storia. Ecco perché ho ritenuto opportuno elencarli tutti ed esprimere il mio ringraziamento per l’opera svolta con generosità e impegno. A questo punto reputo necessario rendere omaggio a tutti i gestori i quali, oltre che svolgere un’attività imprenditoriale difficile e impegnativa, offrono aiuto, soccorso e consigli, controllano il territorio dal punto di vista ecologico e della sentieristica e rappresentano la sezione ed il sodalizio agli occhi di tutti. Ecco i nomi di quelli noti e non citati in precedenza: Vallazza Edith con Zorzi Bruno, Furlan Hans, Ramoser, Nardin, Plankesteiner Hartman, Parisi Marcello con Irsara Otto Schlemmer Walter, Obexer Josef, Schlemmer Alex e Kircher Stefan.

Kircher Stefan con famiglia.
I tanti problemi dell’infrastruttura.
Dopo l’inaugurazione della struttura nel 1964, la documentazione tecnica e la concessione edilizia andarono perdute sia presso l’ufficio tecnico del Comune e sia in sezione. Solo dopo poco meno di 30 anni fu rinvenuta l’autorizzazione all’ampliamento e si provvide a tutte le registrazioni. Negli ultimi 18 anni, anche grazie ai sostanziosi contributi pubblici, il rifugio è stato gradualmente ristrutturato in ogni sua parte, seguendo un elenco delle priorità. Durante la mia presidenza sono stati rifatti il tetto, la coibentazione esterna a “cappotto”, alcuni pavimenti, la scala interna con potenziamento dei servizi igienici, la cucina, compreso il mobilio di acciaio, gli impianti di riscaldamento ed elettrico, la gabbia parafulmine e l’allacciamento alla fognatura comunale, nel frattempo realizzata. A proposito di acque reflue è da segnalare che nel 1993, a causa di un ritardo nella realizzazione della rete fognaria per l’intero territorio della Plose, in programma da diversi anni, la sezione fu costretta ad installare, per un solo anno, un depuratore che prevedeva un separatore “alpimat” e un pozzo perdente. Il Plose, come peraltro quasi tutti i rifugi, era nato e vissuto 106 anni senza fossa biologica. Gli interni sono stati ristrutturati e adeguati alle norme di sicurezza antinfortunistiche, antincendio e sanitarie. Durante la presidenza Santini, sono stati rinnovati il bar, la sala pranzo,le camere, quasi tutti gli arredi del complesso, ampliata la terrazza e rifatto l’acquedotto.
Il grande impegno finanziario e organizzativo per la ristrutturazione ha dato i suoi frutti e il complesso è ora accogliente e funzionale.
Frequenza e manifestazioni .
Numerose e molto frequenti sono state le manifestazioni svolte al rifugio, anche perché si presta in modo particolare, tenuto conto della relativa vicinanza alla città. La struttura ricettiva, inoltre, può essere raggiunta su itinerari diversi e di diversa durata; un’ora e mezza da Valcroce dove c’è il parcheggio anche per gli autobus, tre ore da S. Andrea e in poco più di 4 ore da Bressanone. Infine è possibile e agevole salire con la bicicletta da montagna. Ogni anno dal 1931, come già accennato, si celebra la sagra della Plose. Il programma spazia dalle gare di tiro alla fune a squadre, alla corsa con i sacchi, alla lotteria e, naturalmente, all’immancabile castagnata. Sovente il Coro Plose del CAI Bressanone partecipa e contribuisce alla riuscita della manifestazione. Tra le maggiori manifestazioni effettuate di recente, ricordo il raduno regionale di alpinismo giovanile del 1990, organizzato in massima parte da Gianpietro Gelio. Era in palio il trofeo Miglioranza e venne indetta una gara di disegno cui parteciparono oltre 50 ragazzi. Durante la manifestazione il soccorso alpino della sezione, diretto da Silvano Zucchelli, si esibì in una bella e complessa esercitazione che vide la presenza di due elicotteri (uno dovette allontanarsi per un soccorso reale). Al raduno, che registrò un numero particolarmente elevato di partecipanti, erano presenti autorità, tra queste il vicesindaco di Bressanone Dario Stablum e, naturalmente, Fulvio Gramegna e Vinicio Sarti, presidenti rispettivamente, della commissione di alpinismo giovanile centrale e regionale. Nel 1994, in occasione del 70° anniversario della sezione ebbe luogo un raduno sezionale con un notevole afflusso di Soci e invitati. Il Plose è sempre stato un punto d’incontro di alpinisti, escursionisti e sciatori di molte nazioni e diverse culture con conseguente scambio di nozioni ed esperienze; qui, ad esempio, già nel 1990 conobbi da un turista l’uso del sacco lenzuolo e ne proposi l’adozione durante l’assemblea del CAI Alto Adige nell’autunno del 1992. La proposta fu accettata all’unanimità e il CAI A.A. fu il primo dell’intero sodalizio ad usare l’accessorio pratico, igienico e di grande valenza ecologica. Nei mesi invernali è frequentato da sciatori che praticano la discesa e il fondo, da scialpinisti e dagli appassionati dello snowboard e dello slittino; ognuno può scegliere la pista adatta alle proprie capacità tecniche. Per lo scialpinismo, è da segnalare una gara notturna organizzata dalla squadra di Soccorso alpino del CAI Bressanone, giunta alla quarta edizione. E’da ricordare che la stessa squadra concorre in buona parte al servizio di soccorso piste. Il CAI Bressanone organizza ogni anno un corso sci, con test finale, rivolto principalmente ai bambini, affinché, oltre alla tecnica dello sci da discesa, vengano a contatto e acquisiscano le prime conoscenze della neve e della montagna invernale. Ogni anno viene svolta la gara sociale di sci della sezione di Bressanone e, saltuariamente, la gara di slalom gigante del CAI Alto Adige dedicata al professor Mario Martinelli, presidente della sezione di Bolzano e del CAI Alto Adige stesso. In numerose altre occasioni la nostra struttura è stata frequentata per riunioni, corsi e manifestazioni. Mi piace ricordare che i frequentatori più attenti e rispettosi della natura sono gli alpinisti e gli escursionisti che, a coppie o a gruppi, percorrono le alte vie che passano dal rifugio, per ammirare i panorami sempre belli e diversi, per osservare i fiori, gli alberi e gli animali e per bearsi al sole e all’aria ancora incontaminata delle nostre incantevoli Dolomiti. Vittorio Pacati

il banco bar del rifugio.

angolo self-service.
Notizie pratiche
- RECAPITI: Telefono: rifugio 0472521333 (è anche fax); gestore 3488900919; CAI Bressanone:
0472834943.
Sito Web: plosehuette.com; mail to: plosehuette@dnet.it
- ACCESSI: da Bressanone in 4,5 ore (segnavia 4); da Bressanone seguendo il sentiero n. 6, 5 ore;
da S. Andrea in 3 ore (segnavia 4 ); Da Vacroce in 1,5 ore (segnavia 4 alta via n. 2); da
Luson in 4 ore (segnavia 3).
- TRAVERSATE; al rifugio Genova al Passo Poma in 4 ore (alta via n. 2 e 8).
- ASCENSIONI: Sass Putia su sentiero parzialmente attrezzato, in 7-8 ore ( andata e ritorno).
Monte Forca Grande in 2 ore (andato e ritorno).
- LE ALTE VIE:
- L’alta via di Bressanone: partenza da Valcroce, segnavia 30 fino a rif. Malga Buoi, segnavia 6 fino al rif. Plose indi discesa a Valcroce seguendo il sentiero n. 3, in 5 o 6 ore.
- L’alta via dei Cirmoli: partenza da Valcroce, seguire il segnavia 30 fino a Malga Buoi e ritorno in 3 o 4 ore.
- L’alta via delle Tre Cime; partenza da Valcroce sentiero n. 3, al rif. Plose, piccola deviazione al M. Telegrafo, e poi con il sentiero n. 7 al M. Forca Grande q. 2575 e ritorno a Valcroce in 4 o 5 ore.
- L’alta via delle Dolomiti n. 2 (delle leggende) ha inizio a Bressanone e termine a Feltre. È suddivisa in tappe (da 13 a 16) e comprende numerose varianti. Le montagne più belle e famose che si incontrano nel percorso sono Puez-Odle, Gruppo del Sella (in particolare si transita dal passo Gardena e dal passo Pordoi), Marmolada e le Pale di S. Martino (si transita dai passi Rolle e S. Pellegrino).
La via è stata prolungata da Innsbruck a Bressanone di 9 tappe col nome via Europea perché transita dal rifugio Europa (ex Venna alla Gerla). Il prolungamento da Feltre a Bassano del Grappa, denominato alta via n. 8 delle Prealpi Bellunesi o degli Eroi, consta di 4 tappe.
- L’alta via n. 8 delle Dolomiti inizia a Bressanone e termina a Salorno. È suddivisa in 10/14 tappe e comprende alcune varianti.Fino al rifugio Genova coincide con la n. 2.
- CARTOGRAFIA: Kompass n. 56 Bressanone.
- BIBLIOGRAFIA: -Ed. Sez. Bressanone del CAI AA: Montagne senza confini di Fausto Ruggera,
1994.
-Ed. Athesia: Il Palazzo vescovile di Bressanone di Karl Wolfsgruber, 1988.
|
|
|